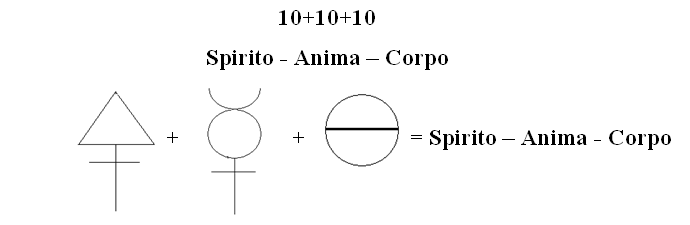UNA
SERIE DI RACCONTI DI NATALE MISSALE
1 Kkienn - Il Creativo
“Dove va il mondo, nonno?”.
La voce del nipotino aveva quasi svegliato il vecchio, che, dagli occhi
aperti, grandi come due finestre, qualche mezz’oretta prima era uscito per
andare a vivere un pò d’esistenza in uno di quei mondi immaginari ove
spesso si recava, ed in cui si sentiva altrettanto vivo che in questo.
“Vedi
figliulo - rispose con voce dolce e tagliente al tempo stesso - il mondo
cui tu ti riferisci è un vecchio cavallo ormai stanco. Da milioni di anni
sta lì legato al palo; da sempre è pronto per essere cavalcato, ma
nessuno, tranne pochissimi saggi, lo ha mai montato.
La maggior parte degli uomini si accontenta di vermi: sì, ogni uomo
sceglie di cavalcare il proprio corpo con la propria mente, ma questa è
un cavaliere-spugna che assorbe tutto ciò che entra nel suo raggio
d’azione. E’ come un campo magnetico che, su una lastra sconfinata di
ferro, agisce solo entro una superficie limitata. Tutto è dovuto ad una
forza centripeta (l’ego) che non consente a quella porzione di ferro, di
rendersi conto della vastità di cui fa parte.
Per tornare
all’esempio del cavallo, diciamo che il cavaliere (la mente) a poco a poco
schiaccia il corpo fino a renderlo un verme; ed i vermi, tu sai benissimo,
sono esseri piani o quasi, che non riescono a vedere le cose “alte”. A
questo punto, il vecchio Kkienn (questo era il suo nome) si curvò,
raccolse un piccolo ramoscello e con esso disegnò a terra sei piccole
linee parallele. Poi tornò ad appoggiare la schiena sul sedile del parco
e, sorridendo, disse al piccolo kkienn (tale era il nome del nipote):
“Sai, l’uomo è l’essere più fortunato dell’intero universo, perché, che
sia illuminato o no, sa di essere un uomo, ma soprattutto è in grado -
unico fra gli animali - di costruirsi il senso dell’“io”, dell’ego.
Per tornare all’esempio di poco fa, è come se una mano sconosciuta, con un
gessetto, avesse disegnato un cerchio su quella superficie di ferro
infinitamente vasta (e capirai certamente che sto parlando del corpo).
Qui devi stare attento: quella mano misteriosa non ha tagliato un disco di
ferro, lo ha solo “disegnato”... Ebbene, è a quella falsa porzione di
superficie che nasce l’idea di “io”, ed a questo punto il gioco comincia:
si è illuminato un…. pezzo di ferro. In effetti, ragazzo mio, ogni uomo,
per il solo fatto di essere nato, è un animale illuminato, un pezzo di
ferro magnetizzato. Dal momento della sua nascita comincerà a muoversi
dentro quel suo piccolo recinto illusorio. Per rendere l’idea di quello
che voglio dire, fai finta di essere sopra un grandissimo tappeto elastico
sulla cui superficie vi sono sferette d’energia. Adesso immagina una
superficie parallela al tappeto che si estende sopra la tua testa e da
cui pendono infiniti oggetti. Ora, siccome ti piace recitare più “io
voglio” che “io sono”, comincerai a raccogliere oggetti dal mondo che ti
sta sulla testa, allora ti appesantirai ed il tuo peso farà abbassare il
tappeto sotto i piedi, e nella coppa che si creerà si precipiteranno tutte
le sfere vicine. Se su di un simile tappeto poni alla rinfusa un po’ di
uomini dello stesso stampo, ti renderai conto di come si apra una vera e
propria caccia alle sfere, anche se indirettamente: l’ego è direttamente
proporzionale a “io ho”. Nella società in cui viviamo avviene proprio
così. Ma non sto criticando tale tipo di comportamento, perché ripeto esso
farà sviluppare sempre più l’ego, il senso di separatività, e ciò, lo
affermo, è importantissimo.”
“Sì,
va bene, nonno; ho capito tutto, ma io t’avevo chiesto dove
andasse il mondo, e non questo”.
“Lo so, lo so mio caro, ma visto e considerato che non hai capito che già
ti ho risposto, sarò ancora più esplicito. Quando dici “io avevo
chiesto”, non ti rendi conto di essere un falso disco di ferro? Torniamo
al nostro paragone, così ci capiremo meglio. E’ come se un disco chiedesse
ad un altro disco dove vanno tutti gli altri dischi, cioè il resto della
sconfinata lamiera. Ma tu sei il mondo, ragazzo mio, non sei una parte di
esso. Fin quando crederai di esserne parte, sarai diviso, ma nell’istante
in cui ti accorgerai anche per un solo secondo, di essere quell’immensa
distesa di metallo, avrai cancellato un po’ di circonferenza, e da quel
momento, avendo già dato un’occhiata oltre l’apparente limite, avrai un
solo scopo nella tua vita, quello di cancellare tutta la circonferenza; da
quel momento saprai di essere, e chi “è” non va da nessuna parte: sta lì a
giocare il gioco più bello del mondo, quello del mutamento, della
partecipazione al cambiamento. Ecco quindi la risposta finale che ti do:
il mondo è. Esso non va da nessuna parte, ma… muta, gioca con se stesso. E
qui veniamo al disegnino che poco fa ho fatto a terra. Quelle sei linee
sono i sei posti del mondo. Il gioco divino (da sempre in atto) fa sì che
il mondo cambi or questo or quel posto, e facendolo crea, nella zona degli
stampi, tutto ciò che poi giù in basso sarà visibile come movimento delle
sfere sul tappeto. Diciamo che al gioco dell’alto (le linee sono fonti di
pensieri, simboli parlanti) corrisponde il cambiamento di colori nel
medio, e che a questo corrisponde poi nel basso un cambiamento
verificabile coi sensi. Adesso ti affido a queste sei piccole linee: esse
sono il mondo, quindi l’antico cavallo. Cavalcale subito, mio caro
ragazzo, perché con esse giungerai fino al più lontano limite del tuo
essere, e così saprai quanto sei grande. Vola su di esse, vola, perché
sono il cielo, il padre del fuoco: esse sono tuo padre, perché tu
ora sei il fuoco, lo spirito ardente. Ti hanno già creato una volta
creando se stesse. Adesso lascia che ti ricreino, che ti facciano
ricordare chi sei. Ma sappi: ad ogni battito d’ali, il cavallo tenterà di
disarcionarti. Se ti aggrapperai alla sua criniera, ciò non potrà mai
avvenire, nonostante la vigorosità del moto del cielo, perché tu,
il nobile, ti sarai reso forte e vigoroso. In effetti il cavallo
che monti è un drago di cui tu sei il fuoco interiore. Rimani in groppa
fermo; non agire all’inizio, ma dopo, quando saprai di essere molto più
grande di quello che sei, quando vedrai il granduomo faccia a faccia,
quando vedrai la tua reale dimensione ed avrai la sensazione di spuntare
da un campo, come un fiore, non vorrai più smettere di cavalcare, lo farai
tutto il giorno. La sera forse sarai un pò stanco, ma tu non ti
abbandonare, rimanigli in groppa persino nel sonno, perché nel chiudere
l’occhio che ha visto, vi è pericolo. Allora, col passare dei
giorni, aumenterà in te la voglia di essere scagliato, di scagliarti come
una freccia verso i tuoi più lontani e inimmaginabili limiti; vorrai
perderti nel tuo mondo infinito. Da allora in avanti tutto sarà puro,
senza una macchia: tutto sarà bello così com’è. Ed ecco: tu sarai il
cielo nel cielo; tu sarai me”.
E nel momento in cui il vecchio Kkienn tacque, il suo mio corpo si
trasformò in cavallo d’oro alato, sulla cui groppa vi era un cavallo d’oro
alato più piccolo (sotto Kkienn il cielo; sopra Kkienn il cielo): anche il
piccolo kkienn si era mutato in cavallo. Entrambi volarono alti nel
cielo, ma nessuno dei due girò il collo per guardare orgogliosamente le
proprie ali, perché nell’attimo in cui era avvenuto il mutamento, una voce
misteriosa ed imperiosa aveva detto: “il drago altezzoso avrà da
pentirsi”. Entrambi sapevano di essere e non essere.
Firmato: Il Creativo.
4 - Mong - La Stoltezza giovanile
“Miei
cari discepoli — esordì il Maestro — per vostra libera scelta vi trovate
oggi qui, per cominciare un corso di studi un po’ particolare.
In questa
scuola non vi sono docenti. La mia umilissima carcassa, la persona fisica
che vi sta davanti, si limiterà, per tutta la durata del corso, ad essere
un punto di riferimento per eventuali imprevisti.
Non
vi sono materie, né libri, né esami; né tantomeno professori.
In un certo
senso, i docenti siete voi. Si, proprio voi. Vi accorgerete presto,
infatti, come sempre per vostra scelta abbiate deciso di sapere; o meglio,
di autosapere.
Qui
vi si dà la possibilità di scoprire le leve che muovono le piccole cose
intorno a voi. Ma ovviamente, e per analogia, come per uno così per un
milione; per cui potrete capire anche le cause delle grandi cose.
L’era elettronica, trova in questa stanza la sua più geniale
manifestazione: la lavamens.
Tutte, diciamo così, le lezioni si svolgeranno alla lavamens.
Di cosa si tratta è intuibile: è una lavagna che, con un termine da mille
e una notte, potremmo definire, magica.
Ad ognuno di voi verrà dato in dotazione un pezzetto di gesso, un panno
spugna, un diario, una penna, ed una chiave.
La chiave apre quella porta a vetri lì in fondo alla stanza che dà sul
giardino.
La genialità della lavamens consiste in questo: col gesso vi si scrive
sopra una frase qualunque, e colui che la scrive diventa protagonista dei
contenuti di essa. Mettiamo che qualcuno scriva “io sorrido”: basta
attendere tre decimi di secondo, et voilà: chi l’ha scritto sorride.
Un mormorio generale si levò. Il maestro con molta calma e indulgenza
aspettò che scemasse, e poi con la stessa pacata voce di prima continuò:
“in un certo senso è come un gioco. Avete due trimestri a disposizione.
Per fare cosa? Per giò-studiare, o se volete, per stu-giocare. Lavorando
di gesso e di panno, potete scrivere e cancellare quello che volete, e
senza obbligo alcuno, potete appuntare ogni vostro effetto-scrittura sul
diario, che potrete comunque usare per promemoria.
In che cosa consista lo studio, dovrete scoprirlo da voi. E adesso; buona
lezione”.
Chiuse la porta dietro le sue spalle, e andò via.
Vi lascio immaginare quel che successe in quell’aula. Come ad un segnale
convenuto i quattro discepoli, gesso alla mano, conquistarono quasi nello
stesso istante, ciascuna la sua porzione di lavamens, e….. non ci
crederete; scrissero la stessa frase. Mo scrisse: “Mo è ricco”; Mon
scrisse: “Mon è ricco”; Mong scrisse: “Mong è ricco”; Gnom scrisse: “Gnom
è ricco”.
Ebbene, finito di scrivere, tutt’e quattro si ritrovarono, ciascuno con
una valigia piena di soldi nella mano sinistra: ne avevano verificato il
contenuto in un attimo: il maestro non aveva mentito.
Mo, Mon e Gnom stavano contando con avidità quei bigliettoni di banca,
quando Mong, non visto, si era portato alla lavamens e stava già scrivendo
“Mong è più ricco di tutti”. Non ci vuole molto per capire in quanti
minuti l’aula si riempì di cartamoneta e di lingotti d’oro; tanto che si
dovette giocar di panno per fare un po’ di spazio e passare ad altro.
Quello fu il primo giorno di lezioni, mentre il maestro, da dietro la
vetrata, dal giardino guardava divertito.
Per non affaticarvi troppo col racconto, farò un breve resoconto di quello
che seguì alla ricchezza: bellissime donne; cavalli puro sangue; libri
rari; pasti da re; vestiti incredibili; motori supersonici; insomma, per
quella stanza passò l’intera storia dell’umanità; e questo in appena
sette giorni.
L’ottavo giorno, il maestro entrò nell’aula, ma anziché 4, vi trovò 3
alunni, che ovviamente erano alla lavamens, a scrivere.
Li chiamò e disse: “Tu, Mo; come vanno i tuoi studi?”
“Il mio Maestro
vorrà scusarmi — rispose Mo — ma sono alle prese con la lingua inglese:
stavo giusto scrivendo “Mo parla l’inglese, ed in quel momento, Voi...”
“Va bene, bravo — gli fece il maestro — E voi ? —
rivolgendosi a Mon e Mong.
“Come
vede, maestro — risposero in coro i due — noi copiamo sulla lavamens le
frasi che via via ci appuntiamo sul diario; e forse ci vorrà una vita per
scriverle tutte. E...”.
“Bene, continuate”— disse loro sorridendo. E andò in giardino. Gnom era
lì, sotto un albero di quercia, e col pollice e l’indice riduceva il
gessetto in polvere. Aveva l’aspetto sereno e dolce.
Appena vide
il maestro, gli sorrise piangendo, e, alzandosi, gli si inchinò con molto
rispetto. Il suo sguardo pareva provenire da una distanza infinita.
Prese tutto quello che si era portato appresso, e lo porse al Maestro: era
il suo diario aperto all’ultima pagina: v’era scritto “GNOM SI E’
ILLUMINATO”.
Il Maestro
sorrise e, a sua volta, offrì un inchino molto rispettoso a Gnom. Dopo
allungò un ultimo sguardo alla scolaresca: “stoltezza giovanile! — disse —
ma passerà”; e trasse un lungo respiro.
Grazie
5 - L’Attesa
La
terra dei padri è un’immensa distesa di verde.
Le tuniche
azzurre dei dodici vecchi-perenni, seduti solenni sul prato, insieme coi
loro capelli di luna, facevano danze col vento. La vita accadeva in
profondo silenzio: sembrava un’attesa infinita. La rosa di luce, lì al
centro del piano cantava l’eterno presente. I vecchi gridavano amore
dagli occhi. Berescit era giunto in quel luogo aspettando, ma la sua era
stata un’attesa di pochi minuti, perché nell’eterno presente l’attesa è
un evento ch’è stato da sempre in un luogo: il tempo di sottrarsi a sé
stesso, ed eccolo là nella terra dei padri. Com’era bello vedere la
grazia! : dal cielo, dall’erba, dai volti, dai petali accesi; da tutto,
emanava.
“Com’è che sei qui, figlio mio — echeggiò la voce felpata di un padre —
cos’è che ti porta fin qui?”
“E’ stata l’attesa, mio nobile vecchio, è stata la voglia che avevo di
essere qua e di viverla insieme con voi che sapete e che siete per
sempre”.
“L’attesa è un mondo racchiuso nell’uovo: sta lì tutto quanto finché col
calore si “svolge”.
La rosa è una mano robusta che picchia alla porta del cuore con tutti i
sapori che ha. Guardala bene, figlio mio, annullati un attimo in essa, e
poi dimmi: dov’è l’attesa dei petali?
Non essere mai stanchi di essere e dirlo a chiunque. Quando la rosa si
china al vento che passa, affida il messaggio anche al vento. Il tuo è un
cuore mai stanco di Dio che cerca sculture di poche parole da dare.
Se stai con la rosa, l’attesa scompare, perché nel profumo che porti ti
perdi per sempre. Allora riposa la lingua e vince il silenzio: più nulla
da dire e da dare: ognuno ce l’ha.”.
Berescit
guardò il fiore di luce e con tutta la forza che aveva gridò:
“l’attesa”!...
La parola
esplose nell’aria come un pronunciamento impersonale, come se si fosse
detta da se’.
Quell’esplosione di verbo disintegrò tutto ciò che essa conteneva: la
parola si liberò del suo contenuto, e divenne canto.
Di eco in eco essa accelerava le sue vibrazioni dando vita ad armonie
cosmiche.
Un profumo di rosa riempì l’aria, mentre i vecchi padri, uno dopo l’altro,
scomparivano come l’ultima fiamma di una candela: rimase solo la rosa, e
dopo, solo la sua luce.
Alla fine, solo il profumo.
Ho la netta sensazione che l’attesa mi abbia nascosto qualcosa, perché
suol vedersi in essa un non so che di statico, mentre qui qualcosa si è
mosso e m’è sfuggito.
E se fosse davvero arrivato qualcosa? Starò più attento la prossima volta,
però se qualcuno l’ha visto... Credo proprio che ognuno di noi è un
albero, e che i frutti abbiano un sapore sconosciuto all’albero
stesso. Ma..., stiamo davvero aspettando qualcosa?
Grazie.
6 - La Lite
Sung era un
piccolo villaggio circondato da un bosco. Berescit, di tanto in tanto, vi
si recava per andare a trovare il vecchio Zuma’.
Quel mattino di primavera aveva deciso di rincontrarlo perche’ era alle
prese con un importante problema: era sicuro, il suo anziano amico lo
avrebbe aiutato a risolverlo.
Zuma’, ancor giovane, era entrato in convento, e vi aveva trascorso trenta
anni della sua vita recitando i sutra del Budda senza averne tratto alcun
beneficio. Si’, era molto cresciuto in spiritualita’, ma in tanto tempo
non gli era riuscito di illuminarsi.
Un giorno, mentre si
trovava a mensa con tutti gli altri monaci, al suono di un campanellino
ebbe la netta sensazione, anzi la certezza assoluta, di “essere... un
cappotto”, un immenso cappotto (l’universo intero) che abbracciava il suo
corpo-mente-cuore da tutte le parti; come se l’intera esistenza poggiasse
sulla sua pelle. A quel punto si alzo’, batte’ forte le mani, fece un
riverente inchino ad una statua del Budda; ne fece un altro al suo maestro
e poi, dicendo: “Ho trovato un cappotto”, si avvio’ verso l’uscio.
Nessuno aveva capito che si era illuminato, ad eccezione del suo maestro,
che inchinandoglisi replico’: “Hai trovato il cappotto, l’unico cappotto
che c’era. Eppure, sei nudo come un verme. Adesso sei l’uomo piu’ comune
che c’e’: sei un Budda!”
A queste parole, tutti i monaci, pur non avendo compreso, fecero un
inchino corale a Zuma’ che intanto aveva varcato la porta.
Tempo dopo, quando Berescit giunse a Sung, trovo’ il maestro seduto su una
panca. Zuma’ con la mano gli fece cenno di sedersi accanto a lui: “Il tuo
e’ un problema molto serio - gli disse come se avesse saputo da sempre la
questione - molto, ma molto serio”.
Berescit ormai non provava piu’ alcuna maraviglia: il vecchio sapeva
sempre i motivi delle sue venute.
“La lite - riprese Zuma’ - e’ una delle tante strade che conduce al vero.
Unica condizione e’ che con essa si varchi ogni limite. Ti racconto
questa, cosi’ mi capirai.
C’era una volta un giovane chiamato Nun: non c’era al mondo persona piu’
litigiosa: all’asilo litigo’ con tutti i compagni di scuola, con la
maestra, col bidello, e persino con il cane del custode. Si racconta che
un giorno riusci’ a litigare anche con un banco. Quando fece la prima
comunione, ovviamente litigo’ col vescovo; col padrino ebbe qualcosa da
dire durante il rinfresco. La prima volta che ando’ al cinema “disputo’”
prima con la maschera, poi con sette spettatori, ed infine con uno dei
protagonisti del film. Alle superiori litigo’ con tutti, e pare che verso
il terzo anno di frequenza si tenne un consiglio di classe straordinario,
nel disperato tentativo di anticipargli il rilascio del diploma di un paio
díanni. Quando sposo’ la sua prima moglie, durante la cerimonia, prima
litigo’ col prete durante il sermone, e subito dopo col suocero. Con due
testimoni si sfioro’ la rissa. La sera, prima di partire per la luna di
miele, litigo’ con la moglie e le chiese il divorzio. Con la seconda
moglie litigo’... durante il fidanzamento, perche’ da sposato non ebbe
tempo, per via del fulmineo divorzio bis. Insomma, non tramontava sole
senza che lui non avesse litigato con qualcuno. Solo una volta gli stava
succedendo il contrario. Si trovava sulla cima di una montagna, ed era
solo perche’, a causa di un litigio di massa, il giorno prima, l’intera
cordata (all’infuori di lui) era finita in un crepaccio. Era solissimo.
Guardo’ in tutte le direzioni: nessuno, nessuno con cui litigare. Si
sentiva un uomo davvero inutile. Ma dopo un po’, un colpo di fortuna: un
serpentello velenoso se ne stava su una roccia, ed immobile porgeva il
dorso agli ultimi raggi di sole. Appena lo vide gliene disse tante che la
lite fu inevitabile. In pratica gli grido’ sette od otto cose che non
andavano. Ovviamente, alla fine, il serpente, convinto che a nulla sarebbe
servito il suo potente veleno, scappo giu’ a valle. Un giorno – continuo’
Zuma’ sottolineando la cosa con un sorriso - Nun incontro’ me, e come al
solito lancio’ la litigata, ma fin dal suo primo “attacco” gli risi in
faccia; e piu’ ridevo e piu’ s’innervosiva; e piu’ s’innervosiva e piu’
ridevo. Alla fine, non potendone piu’, mi disse: “Ma mi spieghi cosa hai
da ridere tanto?”. Ed io gli risposi: “Rido perche’ sei convinto di avere
litigato per tutta una vita, ed io so di certo che tu non hai mai
litigato, perche’ il vero, l’unico autentico litigio e’ quello che uno ha
con se stesso una volta e per sempre”.
Nun non aveva mai pensato a quella remotissima possibilita’: litigare con
se stesso: come mai non ci aveva pensato prima? La cosa lo esaltava, lo
stuzzicava, ma: come fare? Passo’ giorni interi a cercare un pretesto:
niente.
Dopo un anno di sforzi sovrumani, finalmente un giorno gli accadde. Era
davanti allo specchio e si osservava nell’intento di trovare il giusto
spiraglio. Si fisso’ talmente intensamente da quasi trasferire la sua
coscienza nell’immagine dello specchio: a quel punto scaglio’ su di essa
cio’ che aveva in mano, ma appena lo fece, istintivamente, si abbasso’ per
schivare il colpo. Fu un istante, un solo istante, ma gli basto’: si rese
conto di essere due: per la prima volta in vita sua si era manifestata a
lui la sua Coscienza; il suo Dio interiore l’aveva osservato per la prima
volta. Ma la cosa piu’ sbalorditiva fu (cosa mai azzardata prima) che
tento’ di evitare la lite, ma non vi riusci’, perche’ lui, come Coscienza
voleva evitare se stesso, un se stesso che occupava lo stesso identico
corpo. Vi era una sola cosa da fare: essere Uno; ed i modi per farlo erano
due: o farsi assorbire dalla Coscienza (cioe’ fare il mistico e pregare
Essa di farlo); oppure “conquistarsi” lui la sua Coscienza (fare cioe’ il
Mago, agire, lottare). Scelse, ed era prevedibile, la seconda soluzione.
Nun era un Arcangelo, ma ancora non lo sapeva. La battaglia infurio’ per
anni, e non fu la solita lite, perche’ alla fine il “premio” fu immenso:
DIO! - DIO... “IN PERSONA!”.
7 – L’esercito
Il sovrano, con molta pazienza,
aspettò che alla sua tenda giungessero uno ad uno i vari generali in
rappresentanza di tutto l’esercito dell’impero. Lui sarebbe rimasto seduto
sulla sua poltrona posta sulla pedana di legno in posizione tale da poter
ben vedere tutta la “generalità”.
Il primo ad arrivare fu il generale Sci, e poi via via: il generale
Mustafà, il generale Moshè, il generale Santità, il generale Harè, ed
infine il generale Sakià.
Quando tutti si furono seduti dopo aver reso omaggio a sua maestà,
cominciarono gli interventi sul tema “come potenziare l’esercito di Sua
Maestà”.
“C’è troppa dispersione — esordì deciso il generale Sci — troppi sono i
generali. A comandare dovrebbe essere uno e poi, gradualmente, l’esercito
andrebbe disarmato, perché tanto non c’è nessun nemico da combattere. Si
dia il comando supremo a me, e sistemerò tutto in poco tempo”.
“Ma questo è assurdo — saltò su il generale Mustafà — davanti al nostro
esercito non vedo altro che nemici, tutte popolazioni ostili che vanno
combattute, eliminate, trasformate. Si dia a me il comando supremo, ed in
men che non si dica si allargheranno i confini del nostro territorio”.
“Questa poi — disse sorridendo il generale Moshè — è pura follia, dal
momento che i veri confini sono lì nell’abisso sconfinato, irraggiungibili
per gente che non sa nemmeno arrampicarsi sull’albero... Solo
un’intelligenza intuitiva può comandare tutto l’esercito. Se mi
consentite, solo uno che è riuscito a far spuntare alberi dal deserto e
poi a scalarli può comandare, ed io faccio questo da decenni, perché è
tradizione della mia famiglia. Date a me il comando: pre-scelti si nasce,
ed io lo sono nato...”
“C’è un solo comandante supremo qui — disse in modo perentorio il generale
Santità — e quello sono io. Bisogna solo comandare con umiltà, ed io ne ho
tanta perché l’ho imparata a scuola. Da due mila anni la mia è una
famiglia di umili comandanti. Datemi il comando che mi spetta, ed io,
umilmente, distruggerò tutti i nemici”. “Queste sono tutte chiacchiere.
Qui — disse il generale Harè — ciò che conta è una sola cosa: combattere.
Tutti vogliono il comando supremo, ma nessuno pone l’accento sull’unica
cosa seria, il combattere. Solo chi combatte è guerriero, e solo un vero
guerriero può stare a capo di un esercito. Io sono un vero combattente, io
devo essere il comandante supremo”.
“Se uno è ancora uno schiavo — disse per ultimo il generale Sakià —se uno
è ancora schiavo di sé stesso (e qui tutti dicono Io, Io, Io) non può
essere il comandante supremo: solo chi è liberato può esserlo, ed…io
sono liberato”.
Finiti tutti gli interventi, Sua Maestà suonò un campanellino, ed ecco che
da dietro le sue spalle sbucò fuori un bambino dagli occhietti svegli.
Questo è Berescit — disse il Re con tono rispettoso — il mio consigliere
personale. Ha ascoltato tutti i vostri discorsi, ed ora mi darà i giusti
consigli”. Fece un cenno a Berescit come per dire “Su, comincia”, e poi
si sistemò bene sulla poltrona per ascoltare.
“Suggerisco subito a Vostra Maestà — cominciò Berescit —di cambiare titolo
ai... generali di Vostra Maestà: essi non possono più essere chiamati
“generali”, ma... “particolari”. Sì, proprio così: particolari. Poi
suggerisco a Vostra Maestà di avvicendare i particolari di Vostra Maestà
nelle province. Infine, propongo a Vostra Maestà di riconvocare qui fra
un anno i particolari di Vostra Maestà”. Berescit face un inchino e tornò
a porsi alle spalle del Re, il quale, alzandosi, disse: “Così sia fatto”,
e congedò tutti.
Passò un anno.
Tutti i particolari (ex generali) si ritrovarono sotto la stessa tenda,
dopo avere guidato per dodici mesi una nuova provincia: in pratica, i
generali, anzi i “particolari” Sci, Mustafà e Moshè, avevano scambiato le
province coi particolari Santità, Harè e Sakià ed era successo questo: gli
ultimi tre avevano ripetuto le stesse identiche cose che avevano detto
l’anno prima gli altri tre, e viceversa.
Anche questa volta il Re suonò il campanello, e come allora, sbucò da
dietro le sue spalle Berescit.
“Cosa pensi — disse il Re al nostro giovane — di tutto questo? Qualcosa mi
sfugge. Su, dimmi”.
Berescit disse con voce seria e decisa: “Io suggerisco intanto che Vostra
Maestà si faccia una grossa risata. Quindi suggerisco a Vostra Maestà di
indossare la speciale divisa di comandante supremo. Mio nonno, che ha
conosciuto tutti i capostipiti di questi “particolari”, mi ha più volte
testimoniato che erano davvero dei generali, e che sapevano combattere
vere battaglie contro veri nemici. Gli ex generali di Vostra Maestà,
quelli che io chiamo “particolari”, sono solo dei politicanti, perché
solo un politicante può oggi vedere nemici e battaglie esteriori; solo un
politicante, oggi, può tracciare confini. I confini sono caduti da un
pezzo, ma sembrano esistere ancora, perché nei discorsi degli ex generali
di Vostra Maestà è rimasto solo l’eco delle Verità Totali dette dai loro
capostipiti.
Di tanto in tanto va nascendo qualche soldato semplice che, attraverso
l’eco di tali Verità, riesce a risentire la voce ricomposta dei
capostipiti, ed, in un certo modo, riesce a fare un Unico Discorso anziché
sei discorsi. Ebbene, Vostra Maestà, questi sudditi rarissimi di Vostra
Maestà vengono perseguitati e tacciati di follia, ed alla fine eliminati.
Loro sì, sanno che Vostra Maestà è il Comandante Supremo, anche quando non
veste la grande uniforme. Ecco perché suggerisco che Vostra Maestà faccia
riunire qui tutti i folli dell’intero regno: fra essi troverà il generale
che occorre, ed allora Vostra Maesta’ potrà riappendere la grande
uniforme.” Berescit tacque un po’, fece un inchino al Re, ed
aggiungendo: “i miei rispettosi omaggi a Vostra Maestà”, tornò ancora
una volta a porsi alle spalle del Re.
<< “Sotto Kkann, l’abissale, l’acqua; sopra Kkunn, il ricettivo, la
terra”. Confucio non assomiglia per niente a Lao—Tzu. Commentando l’esagramma,
egli fa sì un volo intuitivo per dire che: “Simboleggia l’acqua
sotterranea che si accumula nel sottosuolo...”, però, nel momento in cui
dice la cosa il suo volo ha termine. Confucio ha buttato in aria una
pepita che è ricaduta in terra, non è riuscito a rimanere in aria. Certo,
quello che dice è oro, oro puro, una buona intuizione, ma la sua acqua e
il suo cielo sono di questo mondo>>.
Berescit riprese fiato. Stava discutendo del settimo esagramma dell’I
Ching, l’Esercito, con un suo vecchio amico, Scwà. Scwà era un samurai che
vestiva una strana veste azzurra. I suoi capelli erano legati da un
cordoncino anch’esso azzurro. Le sue ciglia non si chiudevano mai, ed i
suoi occhi, sempre attenti, erano limpidi come un lago di montagna. Scwà,
nella sua vita si era innamorato una sola volta e per sempre: amava la sua
spada, Aìm, che nonostante le mille battaglie non presentava alcuna
scalfitura: era tutta d’oro, ed. al sole brillava come un sole. Quando la
impugnava, si fondeva con essa. La luce di Scwà era la sua spada d’oro.
Il vecchio samurai ascoltò divertito Berescit, ma poi, sorridendo e
approfittando della pausa del giovane, disse: “è bello quello che dici,
degno di un futuro samurai. Mentre parlavi sembravi Confucio e non eri
contento di quello che dicevi. Adesso voglio aiutarti: con la mia adorata
Aìm fenderò l’aria che ci circonda e che racchiude questo spazio—tempo;
aprirò l’Essere ed insieme andremo da Lao—Tzu”. Ecco quindi che si
alzò, sguainò la spada, la offrì al Sole dei Soli con un inchino pieno di
infinita riconoscenza; divaricò le gambe, e con una incredibile velocità e
leggerezza, tagliò l’Essere. Il giovane e il vecchio furono
investiti da un fascio di luce che dall’apertura esplose a ventaglio;
quindi, dopo aver abituato l’occhio alla nuova situazione, videro...
Videro un vecchio dal fisico di un ragazzo. Se ne stava seduto su una
pietra cubica posta sopra una piccola altura. Per cuscino aveva una
bianca pelle d’animale. Il suo corpo cantava il silenzio, ed il suo
respiro era quello di due amanti con Dio. Scwà fece qualche passo, depose
la sua spada ai piedi di Lao—Tzu in segno di rispetto e devozione, e poi
con voce dolce ma ferma disse: “Chi è l’Esercito?”.
Vi fu qualche attimo di silenzio. Dopo Lao—Tzu sorrise, e per tutto il
tempo che lo fece, la risposta venne dalla voce di Berescit. “Per i tuoi
sensi sei tu e la tua forza in perfetta salute, mentre instancabilmente
affili la tua Aìm; ma adesso sono io che ti parlo e che impugno la spada.
Per il tuo occhio è la nuvola, il divino pozzo dell’acqua, la terra dei
cieli che accumula luce bagnata”.
“Ma cosa vuol dire: sei all’inizio...?” disse il samurai.
“L’ordine è il corpo dell’Uno — disse la voce del ragazzo — Esso è
armonia. L’inizio sei tu che muovi te; è questo”: e Lao—Tzu gli lanciò la
spada. “Tutti sono nell’Uno, ma l’Uno non trova posto in tutti, perché non
basta sapere di esserci, occorre esserci nell’ordine e nell’armonia.
Nel mezzo dell’esercito: tu con la tua spada e la tua luce bagnata, tutti
nello stesso istante.
Se lasci la spada alla mano non tagli più l’Essere, ma te: ti dividi,
ottieni un due che spezza le cose legate.
Se ciò dovesse accadere, prima che la spada ubbidisca alla mano,
dissolviti, dissolviti presto lassù nella nuvola.
La mano non è mai la più vecchia, più vecchio sei tu con la mano:
mantieniti in tutto, non farti scappare le cose; ma se ciò dovesse
accaderti, cacciale senza ucciderle, catturale, perché tu sei uno. Mai
vinca la mano: se essa comanda, sei morto.
Sii tu a comandare: ti spetta per patto.
Non essere comune, ma eccezionale. Ordina alle tue parti, fonda stati di
esistenza sempre più alti; fai di ogni tuo organo un centro di ubbidienza
a te stesso. Adopera il tuo uomo che mostri e che porti.
Adesso — disse infine la voce di Berescit sul sorriso di Lao-Tzu — fammi
vedere il tuo Esercito!”
Il samurai con mosse lente e piene di grazia riprese la spada. Si chinò.
Cominciò a girare come un danzatore sufi, proprio come un amante di Dio.
Facendo girare la sua Aìm, riempì di fendenti quello spazio e quel tempo:
come una torcia che girando forma un cerchio di fuoco, così quella lama
dorata, in tutt’uno col corpo di Scwà, formò una sfera di luce che
inghiottì ogni cosa. Più niente.
Berescit se ne
stava seduto comodamente e tranquillamente, con gli avambracci poggiati
sulla scrivania, come un generale che, avendo vinto una battaglia, ha
allentato ogni tensione. Era calmo, tanto calmo da potersi permettere
qualche volo di fantasia: ogni pratica era un piano di battaglia; la
dattilografa, l’aiutante di campo; ed i vari impiegati, ufficiali e
sottufficiali.
Fu così che all’archivista (persona anziana prossima al pensionamento)
che gli aveva portato una lettera da firmare, per gioco mise in bocca
queste parole:
“Ed anche questa è vinta sig. Generale, eh!. Mi dica sig. Generale, come
mai il nemico, pur essendo stato per l’ennesima volta sconfitto,
ricompone sempre le sue fila, e ridichiara guerra?”
“Tenente Bonè - rispose il generale, lasciando di stucco l’archivista -
lei è una mia emanazione - e qui l’archivista fu costretto a sedersi -
una mia buona “creazione”; fa quindi parte del mio esercito bianco.. Ma
ora guardi” e col dito indicò sopra la propria testa.
L’archivista guardò (ma questa volta lo fece da tenente...), e vide come
dalla testa del generale cominciasse ad uscire, dapprima un fumo, e poi
dei colori; quindi osservò come il tutto, piano piano, assumesse i
contorni di un soldato, uno strano soldato simile più ad un merceneraio,
il quale teneva arrotolata nella destra la solenne promessa. Appena i
contorni di esso furono netti e chiari, si staccò dalla testa del
generale e andò a sedersi proprio accanto al tenente, che intanto aveva
completamente dimenticato di essere un archivista prossimo alla
pensione.
“Adesso guarda ancora” riprese il generale, e nello stesso momento dalla
sua testa cominciarono ad uscire diversi soldati, ciascuno con nella
destra la solenne promessa in pergamena: l’ufficio, che oramai era una
tenda da campo, fu pieno zeppo di soldati. “Ora - disse il generale -
puoi chiedermi qualunque cosa” e sorrise come compiaciuto.
“Ma qui c’è un esercito! - disse il tenente Bonè stupito ed in preda ad
eccitazione - ma chi sono costoro?”
“Lo hai appena detto, mio caro Bonè: questi personaggi costituiscono
proprio l’esercito, ma…. quello nemico, quello che si ricompone
sempre... Sappi, amico mio, che ognuno di noi può utilizzare tutta la
materia mentale che vuole, “creando” tutte le forme che vuole. Ora,
quando “crea” un’immagine netta di se stesso alle prese con una
soddisfazione di desiderio che poi non soddisfa, quel personaggio si
ritrova con una solenne promessa scritta, cioè con un desiderio da
realizzare. Capirai come una persona molto desiderosa, in una sola
giornata possa creare un reparto al completo. Ebbene, nel momento in cui
non mantiene la promessa, il personaggio gli muoverà guerra. Qui è da
sottolineare che ogni soldato va per proprio conto, ma metti insieme
cento, mille persone che ciascuna per proprio conto ti muove guerra, e
vedrai di fronte a te un esercito nemico in piena regola. A questo
punto occorre un esercito amico, ma il primo passo da fare è vestirsi da
generale (all’esercito è d’uopo perseveranza e un uomo forte); e poi…
caro Filipponi... fare di ogni personaggio vero che lei recita nell’arco
di una giornata (o di una vita) un soldato bianco da opporre ai
mercenari insoddisfatti”.
“Ma io sono il tenente Bon...” stava per dire l’archivista Filipponi.
Invece Berescit lo interruppe, e: “Caro Filipponi - gli disse
togliendogli dalle mani la lettera - le firmo subito il congedo
illimitato e le dico pure come far scomparire questa compagnia”. Firmò
la lettera e aggiunse: “Caro Bonè - e qui l’archivista perse ogni
traccia di identità - tolga a ognuno la promessa solenne e la bruci:
scompariranno”, fece quindi una pausa per concludere: “Ma lei...
Filipponi... il fuoco.. ce l’ha?”
Grazie.
7 – L’Esercito(2)
<< “Sotto Kkann,
l’abissale, l’acqua; sopra Kkunn, il ricettivo, la terra”. Confucio non
assomiglia per niente a Lao—Tzu. Commentando l’esagramma, egli fa sì un
volo intuitivo per dire che: “Simboleggia l’acqua sotterranea che si
accumula nel sottosuolo...”, però, nel momento in cui dice la cosa il
suo volo ha termine. Confucio ha buttato in aria una pepita che è
ricaduta in terra, non è riuscito a rimanere in aria. Certo, quello che
dice è oro, oro puro, una buona intuizione, ma la sua acqua e il suo
cielo sono di questo mondo>>.
Berescit riprese fiato. Stava discutendo del settimo esagramma dell’I
Ching, l’Esercito, con un suo vecchio amico, Scwà. Scwà era un samurai
che vestiva una strana veste azzurra. I suoi capelli erano legati da un
cordoncino anch’esso azzurro. Le sue ciglia non si chiudevano mai, ed i
suoi occhi, sempre attenti, erano limpidi come un lago di montagna. Scwà,
nella sua vita si era innamorato una sola volta e per sempre: amava la
sua spada, Aìm, che nonostante le mille battaglie non presentava alcuna
scalfitura: era tutta d’oro, ed. al sole brillava come un sole. Quando
la impugnava, si fondeva con essa. La luce di Scwà era la sua spada
d’oro.
Il vecchio samurai ascoltò divertito Berescit, ma poi, sorridendo e
approfittando della pausa del giovane, disse: “è bello quello che dici,
degno di un futuro samurai. Mentre parlavi sembravi Confucio e non eri
contento di quello che dicevi. Adesso voglio aiutarti: con la mia
adorata Aìm fenderò l’aria che ci circonda e che racchiude questo
spazio—tempo; aprirò l’Essere ed insieme andremo da Lao—Tzu”.
Ecco quindi che si alzò, sguainò la spada, la offrì al Sole dei Soli con
un inchino pieno di infinita riconoscenza; divaricò le gambe, e con una
incredibile velocità e leggerezza, tagliò l’Essere. Il giovane e
il vecchio furono investiti da un fascio di luce che dall’apertura
esplose a ventaglio; quindi, dopo aver abituato l’occhio alla nuova
situazione, videro...
Videro un vecchio dal fisico di un ragazzo. Se ne stava seduto su una
pietra cubica posta sopra una piccola altura. Per cuscino aveva una
bianca pelle d’animale. Il suo corpo cantava il silenzio, ed il suo
respiro era quello di due amanti con Dio. Scwà fece qualche passo,
depose la sua spada ai piedi di Lao—Tzu in segno di rispetto e
devozione, e poi con voce dolce ma ferma disse: “Chi è l’Esercito?”.
Vi fu qualche attimo di silenzio. Dopo Lao—Tzu sorrise, e per tutto il
tempo che lo fece, la risposta venne dalla voce di Berescit. “Per i tuoi
sensi sei tu e la tua forza in perfetta salute, mentre instancabilmente
affili la tua Aìm; ma adesso sono io che ti parlo e che impugno la
spada. Per il tuo occhio è la nuvola, il divino pozzo dell’acqua, la
terra dei cieli che accumula luce bagnata”.
“Ma cosa vuol dire: sei all’inizio...?” disse il samurai.
“L’ordine è il corpo dell’Uno — disse la voce del ragazzo — Esso è
armonia. L’inizio sei tu che muovi te; è questo”: e Lao—Tzu gli lanciò
la spada. “Tutti sono nell’Uno, ma l’Uno non trova posto in tutti,
perché non basta sapere di esserci, occorre esserci nell’ordine e
nell’armonia.
Nel mezzo dell’esercito: tu con la tua spada e la tua luce bagnata,
tutti nello stesso istante.
Se lasci la spada alla mano non tagli più l’Essere, ma te: ti dividi,
ottieni un due che spezza le cose legate.
Se ciò dovesse accadere, prima che la spada ubbidisca alla mano,
dissolviti, dissolviti presto lassù nella nuvola.
La mano non è mai la più vecchia, più vecchio sei tu con la mano:
mantieniti in tutto, non farti scappare le cose; ma se ciò dovesse
accaderti, cacciale senza ucciderle, catturale, perché tu sei uno. Mai
vinca la mano: se essa comanda, sei morto.
Sii tu a comandare: ti spetta per patto.
Non essere comune, ma eccezionale. Ordina alle tue parti, fonda stati di
esistenza sempre più alti; fai di ogni tuo organo un centro di
ubbidienza a te stesso. Adopera il tuo uomo che mostri e che
porti.
Adesso — disse infine la voce di Berescit sul sorriso di Lao-Tzu — fammi
vedere il tuo Esercito!”
Il samurai con mosse lente e piene di grazia riprese la spada. Si chinò.
Cominciò a girare come un danzatore sufi, proprio come un amante di Dio.
Facendo girare la sua Aìm, riempì di fendenti quello spazio e quel
tempo: come una torcia che girando forma un cerchio di fuoco, così
quella lama dorata, in tutt’uno col corpo di Scwà, formò una sfera di
luce che inghiottì ogni cosa. Più niente.
7 – l’Esercito(3)
Berescit se ne stava seduto
comodamente e tranquillamente, con gli avambracci poggiati sulla
scrivania, come un generale che, avendo vinto una battaglia, ha
allentato ogni tensione. Era calmo, tanto calmo da potersi permettere
qualche volo di fantasia: ogni pratica era un piano di battaglia; la
dattilografa, l’aiutante di campo; ed i vari impiegati, ufficiali e
sottufficiali.
Fu così che all’archivista (persona anziana prossima al pensionamento)
che gli aveva portato una lettera da firmare, per gioco mise in bocca
queste parole:
“Ed anche questa è vinta sig. Generale, eh!. Mi dica sig. Generale, come
mai il nemico, pur essendo stato per l’ennesima volta sconfitto,
ricompone sempre le sue fila, e ridichiara guerra?”
“Tenente Bonè - rispose il generale, lasciando di stucco l’archivista -
lei è una mia emanazione - e qui l’archivista fu costretto a sedersi -
una mia buona “creazione”; fa quindi parte del mio esercito bianco.. Ma
ora guardi” e col dito indicò sopra la propria testa.
L’archivista guardò (ma questa volta lo fece da tenente...), e vide come
dalla testa del generale cominciasse ad uscire, dapprima un fumo, e poi
dei colori; quindi osservò come il tutto, piano piano, assumesse i
contorni di un soldato, uno strano soldato simile più ad un merceneraio,
il quale teneva arrotolata nella destra la solenne promessa. Appena i
contorni di esso furono netti e chiari, si staccò dalla testa del
generale e andò a sedersi proprio accanto al tenente, che intanto aveva
completamente dimenticato di essere un archivista prossimo alla
pensione.
“Adesso guarda ancora” riprese il generale, e nello stesso momento dalla
sua testa cominciarono ad uscire diversi soldati, ciascuno con nella
destra la solenne promessa in pergamena: l’ufficio, che oramai era una
tenda da campo, fu pieno zeppo di soldati. “Ora - disse il generale -
puoi chiedermi qualunque cosa” e sorrise come compiaciuto.
“Ma qui c’è un esercito! - disse il tenente Bonè stupito ed in preda ad
eccitazione - ma chi sono costoro?”
“Lo hai appena detto, mio caro Bonè: questi personaggi costituiscono
proprio l’esercito, ma…. quello nemico, quello che si ricompone
sempre... Sappi, amico mio, che ognuno di noi può utilizzare tutta la
materia mentale che vuole, “creando” tutte le forme che vuole. Ora,
quando “crea” un’immagine netta di se stesso alle prese con una
soddisfazione di desiderio che poi non soddisfa, quel personaggio si
ritrova con una solenne promessa scritta, cioè con un desiderio da
realizzare. Capirai come una persona molto desiderosa, in una sola
giornata possa creare un reparto al completo. Ebbene, nel momento in cui
non mantiene la promessa, il personaggio gli muoverà guerra. Qui è da
sottolineare che ogni soldato va per proprio conto, ma metti insieme
cento, mille persone che ciascuna per proprio conto ti muove guerra, e
vedrai di fronte a te un esercito nemico in piena regola. A questo
punto occorre un esercito amico, ma il primo passo da fare è vestirsi da
generale (all’esercito è d’uopo perseveranza e un uomo forte); e poi…
caro Filipponi... fare di ogni personaggio vero che lei recita nell’arco
di una giornata (o di una vita) un soldato bianco da opporre ai
mercenari insoddisfatti”.
“Ma io sono il tenente Bon...” stava per dire l’archivista Filipponi.
Invece Berescit lo interruppe, e: “Caro Filipponi - gli disse
togliendogli dalle mani la lettera - le firmo subito il congedo
illimitato e le dico pure come far scomparire questa compagnia”. Firmò
la lettera e aggiunse: “Caro Bonè - e qui l’archivista perse ogni
traccia di identità - tolga a ognuno la promessa solenne e la bruci:
scompariranno”, fece quindi una pausa per concludere: “Ma lei...
Filipponi... il fuoco.. ce l’ha?”
Grazie.
11 La Pace
Berescit aveva oramai
deciso: avrebbe condotto una seria ricerca sull’esagramma undici dell’I
Ching in una maniera insolita.
Si era procurato, in un mercatino delle pulci, delle vecchie statue di
legno, imitazioni di capolavori di grandi maestri. Lui sapeva benissimo
che attraverso i canali dell’arte, della vera arte, sono precipitate da
sempre delle grandi verità. Erano davvero identiche agli originali: un
Mosè; un Cristo nel deserto; un Budda nella posizione del loto; un
Lao-Tzu nella posizione del mungitore; un Boddidarma davanti al muro; un
Maometto al cospetto dell’arcangelo Gabriele; una comitiva di maestri
zen a braccetto. Se 1e era messe davanti a semicerchio e, con un leggero
movimento del collo, poteva vederle tutte senza muovere la testa. In un
primo momento aveva deciso di fissarle ben bene e di cogliere il senso
sottile della pace che da ogni sculturina gli sarebbe piovuta, ma dopo
aver fissato la prima, quella della comitiva di maestri zen, gli accadde
un fatto insolito: la sua coscienza entrava nella allegra comitiva e,
penetrandola, s’imbatteva in un mondo di rumorosi silenzi. A catturare
la sua coscienza era stato lo strano sorriso che emanava dagli occhi di
quella “banda” di maestri: era in essi la stessa gioia che, cogliendo di
sorpresa un bambino, lo lascia lì senza fiato, come in un atteggiamento
di stupore, e lo solleva quasi fisicamente dal terreno. Riuscì a sentire
in quel rumoroso silenzio la voce della gioia perfetta, la voce
dell’estasi superiore, la voce dello stesso silenzio. Poi cominciò a
nuotare in essa, per divenirne l’essenza. “Ecco - risuonò il coro muto
dei maestri - la pace è l’essenza del silenzio. Non dirla mai, non
l’affermare mai, perché se no la tradisci. Rispettala con lo stesso
stupore con cui un bambino stupito la tace. Non tradirla con sorrisi o
con parole, ma, come noi, apri le tue finestre: i tuoi occhi: sono esse
le aperture con cui puoi sorriderla. Però, facendolo, non compiacerti,
ma rimani in naturale, spontanea apnea: non prendere aria: il tuo cuore
respirerà per te, non avrai bisogno di aria per un po’! Questo è un vero
respiro: il piccolo se ne va e il grande se ne viene. Se respiri col
naso: il grande se ne va e il piccolo se ne viene. Un fortissimo odore
di muschio restituì a Berescit la sua coscienza ed il suo sguardo era
posato sulla statuetta del profeta di Hallah il Misericordioso. Maometto
era al cospetto dell’Arcangelo Gabriele il quale, nonostante
l’immobilità del legno, nonostante il silenzio della figura, emanava un
pregnante sapore di vero, tutto racchiuso nel messaggio che l’assoluto
riponeva nel suo tacere. Questa volta la gioia del bambino esplodeva in
un canto incontenibile: sure di Maometto diventavano un inno
all’Assoluto cantato dal cuore, ed ogni parola avvampava d’amore. A quel
punto, il profeta, pur cantando, taceva, perché la canzone di un faro è
un dolce silente richiamo che va al di là della spada e della lotta;
trascende tutto per divenire la pace. Gabriele è il Cielo, Maometto è la
terra, e congiunti là, in quel modo, sono lo specchio della pace di
Hallah. Il profeta allora diventa un re di diritto e amministra e
ordina i doni di cielo e terra, e assiste il popolo: tutto quello che fa
è perfetto. “La pace è moto ordinato dell’assoluto” echeggiò la voce di
Mohammad. E qui Berescit si ritrovò ancora una volta in se stesso.
Il suo sguardo si era posato sulla statuina di Bodhidharma davanti al
muro. Dopo anni aveva finalmente capito, Berescit si era reso conto di
cosa quel muro rappresentasse per il ricercatore. Esso era lo specchio
davanti a cui l’Essere del grande iniziatore dello zen poneva il suo
involucro. Il muro era un’arma formidabile di cui il maestro si serviva
per annullare di colpo lo spazio e con esso il tempo. Davanti a quella
parete, il corpo (la materializzazione dell’essenza) veniva ributtato a
se stesso, la coscienza veniva così rigettata dentro le mura del suo
tempo, non veniva più attratta dai pallidi riflessi della vita. In quel
modo, la mente taceva e la pace imperava. Il corpo di Bodhidharma, come
una roccia, sfidava il silenzio del muro, e vinceva perché più silente:
primo uomo al mondo, alzava se stesso per i capelli: svellendo
fallarica viene via anche la zolla. Quando, poco dopo, lo sguardo di
Berescit si posò sulla statuetta di Lao-Tzu, non successe niente, ma
proprio niente; quel niente che a priori mette paura, ma che, come
ultima meta, non lascia più spazi. In quella strana posizione Lao-Tzu
mungeva l’Assoluto e non si curava di niente. Un matto, sembrava proprio
un matto; ma solo un divino matto come lui avrebbe potuto comprendere
quella sottile pazzia. Per un attimo Berescit avvertì un Muuuhh, ma di
mucche non vi era ombra. “Certamente echeggia nell’aria rarefatta il
“Muh” di Joshu (il cane ha la stessa natura del Budda?— fu chiesto a
Joshu. La sua risposta fu: “Muh”, che vuol dire nulla, niente). Lao-Tzu
camminava perfettamente nel mezzo. Stavolta Berescit entrò nel sorriso
del Budda, i cui occhi erano socchiusi!. Ma una stranissima sensazione
lo sconcertò: si sentiva come acqua bevuta da un assetato, come pane
mangiato da un affamato: era lui la causa di quel sorriso; ma non lui
come corpo, bensì come essere. Sì, a quel tempo non era ancora nato, ma
un’affermazione gli s’impose dappertutto: prima che Budda fosse, IO
SONO; Io Sono prima che Abramo fosse. Un corpo destinato a morire
esplodeva in un eterno sorriso. A questo punto Berescit trasse un lungo
respiro, quindi posò lo sguardo sul legno raffigurante il Maestro di
Nazareth nel deserto. Prima ancora di entrarvi dentro, nelle sue
orecchie echeggiò: “Nessun piano cui non segue un declino, nessuna
andata cui non segua un ritorno...egli cala aleggiando senza far pesare
la ricchezza, insieme al suo prossimo schietto e sincero”. Cosa
volevano dire quelle parole così misteriose? Berescit entrò in quella
statuina, e appena dentro disse: sono, io, il tuo Krisna, la tua
coscienza cristica, la tua consapevolezza. Quando io mi manifesto tu
diventi umile e tutto va bene. La tua ricchezza interiore sono io, io
sono il tuo “Oro”. A questo punto anche il tuo corpo risplende, ma solo
dopo la desertificazione io mi mostro a te, ed ecco: la pace, ovvero IO
in te SONO: il piccolo se ne va, il GRANDE se ne viene. Mosè guardava
lontano, lontanissimo. Il suo sguardo non si posava mai. Tutto Mosè era
uno sguardo potente. La legge. E’ come un sacerdote che celebra
continuamente, che costantemente posa gli occhi impavidi sul divino. E’
forte, e attraverso lo sguardo posa la sua essenza sulla Assolutezza: dà
in sposa sua figlia, e ciò è la sua forza, la sua prosperità, la sua
salute. Mancava una variante, e statuine non ce n’erano più. Allora
Berescit entrò in se stesso, ma, mentre procedeva, una voce lo ammonì:
“quando cominci a scavarti devi saperlo fare, perché se non usi i dovuti
accorgimenti diventi come una buca la cui terra appena estratta vi
ricade dentro. Non bisogna adoperare eserciti, non bisogna usare armi
per vivisezionarsi, ma le mani per modellarsi.
Sii l’artista della tua creta; prendi il comando e annuncia i tuoi
decreti. E persevera, scavati sempre. Sii un artista, e.. chissà!..
forse un giorno non lontano qualcuno potrà farti visita attraverso un
silenzioso sorriso”.
SHANTI
che vuol dire P A C E.
12 – IL RISTAGNO
Per quale stranissimo
fenomeno — si chiedeva Berescit — dopo avere letto un brano di un
qualunque testo sacro, ci si sente come un cavallo voglioso di
galoppare o come un coniglio saltellante? Sicuramente è come un far
benzina, ma… che tipo di benzina? e… dove si trova?
Certo non sta nel libro, ma è il libro che dà la chiave del serbatoio.
Tu leggi e rileggi il testo, e poi cominci a riempirti di qualcosa che
prima non c’era e che cercherà di uscir fuori sotto forma di creatività.
Ma, attenzione, può essere creativo anche il silenzio, anzi è proprio il
silenzio il punto di partenza di ogni atto creativo. Lo stato di
pienezza rimane intatto se la creatività rimane potenziale e latente
sotto forma di amore verso tutto e verso tutti. Ma quando il maestro è
perfetto, riuscendo a condensarlo in poche parole potenti (vedi Lao-Tzu
o il Maestro) lo passa, lo deve passare. Lo hanno fatto tutti. L’I Ching
lo fa da millenni con pochissime parole, e non si è ancora esaurito,
perché racchiude potenzialmente una delle più grandi verità: il
movimento. Apparentemente ogni esagramma, col suo simbolo e con la sua
sentenza-immagine, è un archetipo, ma di fatto è un evento, è il
movimento incessante e sempre fresco che sta all’interno dello stessa
archetipo. Per fare un esempio diciamo che ogni esagramma è come una
persona, e che anziché farcela conoscere con una foto, l’I Ching ce la
presenta prima con un piccolo filmato (immagine e sentenza in fermento),
e dopo, tramite gli atteggiamenti della persona, attraverso ciò che
essa fa. Ogni archetipo nasce, cresce e muore in tutti gli altri, come
dire: non muore mai; più o meno come la verità di un uomo contiene la
verità di tutti gli uomini, e come la morte di un uomo non significa la
morte dell’uomo. Un granello di sabbia, una goccia d’acqua, contengono
la verità dell’intero universo. Come potrà mai — si chiedeva ancora
Berescit — esaurirsi un tale messaggio? E’ come la voce di una sorgente
che lassù in montagna si rinnova costantemente: il suo canto, sempre
diverso, è fondamentalmente sempre uguale. Fluisce sempre, e nonostante
si versa come acqua continuamente nell’oceano, non si stanca mai di
farlo. Sorgente, fiume, oceano, con tutto ciò che comporta un tale
percorso: anse, laghi, ecc., tutti aspetti e mutamenti della stessa
acqua canterina di montagna. Quando la creatività (la sorgente) con moto
ininterrotto s’insinua tra i sassi dell’alta montagna per lasciarsi
andare verso la valle, prima o poi comincia ad essere nutrita dal mondo
circostante, comincia a diventare fiume. Questi apporti sono come
varianti, le quali danno al fiume un aspetto sempre diverso. Il fiume
dell’I Ching è sempre scorso e sempre scorrerà. Nei suoi 64 tratti
diversi esso appare come un fiume spiralato; ha sempre un inizio e una
fine a dimensioni via via più alte, diverse. Non potrà mai avere fine
perché la sua sorgente nasce nel silenzio, nel Tao. E mari sempre più
vasti, uno sull’altro, riempiendo il cielo e la terra danno
testimonianza di ciò: NON esiste alcun ristagno. L’esagramma 12 del
libro dei mutamenti è un laghetto, è il fiume dell’I Ching fattosi
lago. A prima vista sembrerebbe che esso si allarghi in un’immensa
conca, per ristagnarvi, ma deboli correnti superficiali e subacquee
rinnovano incessantemente le acque facendole mutare. Più a valle il
fiume riprende in suo corso, il lago si riveste da fiume, il lago
diventa uno dei tanti aspetti del fiume. “Il grande se ne va e il
piccolo se ne viene”. Chi è il grande e chi il piccolo? Berescit questa
volta tacque a se stesso perché la domanda l’aveva posta all’I Ching. Lo
aprì a caso e lesse: “L’Esaurimento”. Ma mentre leggeva, apparve nella
sua mente una enorme clessidra: “sempre — si disse — in ogni movimento
c’è un grande che va e un piccolo che viene: è lo stesso archetipo del
ristagno che, passando da sopra a sotto, come immagine, dà l’esatta
natura di se stesso. Il fiume si fa sabbia, ma nulla cambia; il ristagno
diventa un piccolo I Ching, un piccolo Libro dei Mutamenti, ed ogni
linea, a sua volta, diventa un ancor più piccolo libro, un ancor più
piccolo fiume. E’ la goccia d’acqua che contiene il principio
dell’oceano; è il granello di sabbia che contiene il deserto; il
granello di senape che porta in se’ l’albero. L’infinitamente piccolo e
l’infinitamente grande si allontanano e pur s’avvicinano; i due opposti
trovano un punto di coincidenza in qualcosa che può essere reso solo con
la parola SILENZIO. Qui, il Ristagno diventa stupore incomunicabile,
diventa uno stato d’animo. Esso si è staccato dal libro ed agisce su me:
adesso il fiume sono io e mi osservo; ed il mio osservare è un continuo
essere freschi: ed ecco la sorgente......
Quando un fiume sente se stesso alla foce, nel lago, e alla sorgente,
nasce un “moto” al di là di ogni spazio e al di là di ogni tempo. E’ un
ristagno, uno strano irrequieto ristagno. Ecco, è finita: il grande se
ne va e il piccolo se ne viene: ovvero: il silenzio è andato via, il
grande è scomparso; il piccolo (il blaterare) è qui, anzi…era qui,
perché, per fortuna — disse Berescit — appena metterà il punto sarà
nuovamente silenzio, ed il sottile legame che ci unisce tutti sarà
ristabilito: non sarò più un fiume che s’è visto allo specchio, ma
10.000 fiumi. E’ questa la compagnia fra uomini, ma di questo ne
riparleremo un’altra volta”.
Berescit si era reso conto di un fatto incredibile: non vi era alcuna
differenza di tempo…. tra l’attimo in cui trasformava in fiume un
esagramma e questo momento qui… perché sotto ad ogni parola, sotto ad
ogni immagine, la materia prima con cui l’una e le altre venivano
formate incalzava da tutte le parti per imporsi su tutto, per avvolgere
tutto. E’, quello, l’infinito presente: il silenzio, la Forza da cui
promana il Verbo.
SCIIIII…..
16 – IL FERVORE
Sentenza: propizio è
costituire aiutanti e far marciare eserciti.
Berescit si chiese subito: a chi è propizio?… Far marciare eserciti
verso dove?... E perché?… Propizio a che cosa?… E infine: sentenza da
parte di chi?…
La risposta ancora una volta venne automatica: “ti sei imbattuto nella
sedicesima tappa del viaggio da fermi, l’unico modo di viaggiare che
crea movimento. E’ difatti indispensabile tacere prima di parlare,
inspirare prima di espirare, star fermi prima di andare. L’esagramma,
con i suoi trigrammi di sotto e di sopra, è come un panino aperto da un
affamato, che chiede a te, a te che lo osservi, di farti companatico. Se
ti lasci imbottire, se sacrifichi un po’ di te, del tuo essere, del tuo
tempo, della tua apparente individuale energia, allora produrrai un
mutamento nel tutto. E’ questo l’unico modo (si fa per dire) per animare
il libro. Nel mondo vi sono milioni di libri, ma solo pochi fra di essi
ti permettono di far questo. Stiamo parlando dei testi sacri!. Pensa,
milioni di libri scaturiti tutti da una ventina di lettere d’alfabeto.
L’I Ching ha racchiuso tutti i libri del mondo in 64 esagrammi, ma al
suo interno ha fatto di più: ogni esagramma, potenzialmente, li contiene
tutti. Ed infine dà la chiave di tutto il gioco in un’immagine semplice
e perfetta:
UNA LINEA INTERA IMPROVVISAMENTE SI SPEZZA…, una sottile nuvola si
spezza in due a causa del vento. Cos’è che fa spezzare le linee? Qual’è
il misterioso vento che soffia su di esse? Dov’è l’anima dell’I Ching?...
E’ il Verbo, il pronunciamento di una sentenza e di un’immagine, le
quali rappresentano la voce dell’esagramma. Quando stai davanti a un
esagramma è come stare davanti a un bambino, davanti alla perfezione
divina silenti. Egli se ne sta lì zitto, ma appena lo chiami, ecco che
si manifesta, esplode, come un vulcano, con la sua vocina. E’ un fatto
talmente scontato, talmente normale che nessuno ci fa caso; parlare è
manifestare il divino in modo netto e inequivocabile, ma com’è molto più
bello sapere di farlo.. Saperlo equivale a “Fervore”. Per rimanere in
tema, è come un bambino che alla vista della mamma e del papà non
riesce più a contenersi ed esplode nella sua gioia. Ma veniamo alle
domande. E’ certo che un testo sacro è per tutti!. Abbiamo appena visto
il fervore di chi porta a spasso il suo Dio e di ciò ha un barlume.
Vediamolo adesso in chi Lo porta a spasso e non lo sa. Per scoprirlo 1’I
Ching suggerisce di costituire aiutanti e far marciare eserciti; l’I
Ching sta dicendo in un modo allegorico: non essere diviso, prendi il
comando di tutte le tue regioni e organizza le tue folle (i tuoi ego);
disciplinali, falli marciare. E’ il primo passo per stabilire la pace
in te e per orientare tutti i tuoi sensi in una sola direzione. Ciò
deve essere fatto con una perentorietà simile a quella del tuono che
sta per affermare il cambiamento del tempo. Irrompi in te stesso, fai
tuonare il tuo Verbo caricandolo di Cristicità: lascia che il tuo
Signore comandi tramite il suo vassallo. Sottomettiti a Lui, al tuo
Sovrano:solo così potrai diventare vero Re. Gli antichi re lo sapevano,
e dopo aver fatto esplodere in loro il tuono, vedevano nella tempesta
successiva la sacra musica, quella del sacro mutamento. Sacrificavano
ogni loro tempesta interiore al Dio Supremo ed in quella offerta
lasciavano bruciare al fuoco appena acceso la presenza dei loro avi,
cioè tutto quello che costituiva la folla delle loro tante personalità.
Il tuono è annunciatore della tempesta, è la voce del cambiamento.
Quando esso arriva, gioisci, non aver paura: il Verbo è esploso in te.
Mettiti da parte a osserva i venti, le nuvole nere, la pioggia e i
fulmini. Solo così potrai purificare la tua terra. Offri te stesso alla
tempesta, pulisciti, sii attento più ai suoi effetti benefici che a
quelli distruttivi. Se si spezza qualche ramo è perché ti sei
irrigidito, ti sei opposto ai venti e all’acqua, non ti sei saputo
piegare umilmente. Il pericolo sta tutto in questo eventuale
irrigidimento. Impara dalla natura: l’albero orgoglioso e forte si
spezza; quello umile, docile, si piega e non si spezza. La tempesta
passerà, l’eco del tuono si allontanerà, ed un fervore nuovo, diverso,
ti scuoterà in tutta la tua nuova e rinnovata natura. Non disperare, la
tempesta passerà. Non aver paura, essa farà solo il suo dovere: monderà
tutto e in fretta. Quando al mattino la voce non riesce a svegliare il
bambino, la mamma è costretta a tuonare e scuotere sia pur dolcemente
suo figlio. L’I Ching ti sta dicendo la stessa cosa: quando la tua anima
dorme e la voce insistente del tuo Dio interiore non riesce a
richiamarla dal sonno, Lui è costretto a tuonare. E’ l’unico modo sai?
La tempesta a volte è proprio necessaria. Certo, essa ti staccherà a
forza da un sonno che non finiva più; ti farà toccare con mano
l’inconsistenza dei tuoi sogni, te li brucerà con un colpo di fulmine.
Quello è un giusto momento: stai attento: la luce del fulmine per
qualche attimo illumina il paesaggio. A quel punto guarda, osservati, è
un’opportunità unica: in quel attimo sei sveglio, ma se ricadi nel
sonno, la tempesta diventa un brutto sogno come gli altri, forse il più
brutto sogno della tua vita. Ed essa continuerà fino a che, o ti
svegli, o ti spezzi.
A te la scelta….
Infervorati quindi, sii come una gallina sull’uovo. Alimenta il tuo
fuoco: la luce del lampo può essere imbrigliata accettandola. Covati,
non disperdere il tuo fervore, non estrinsecarlo, sii saldo e muto come
una pietra: conoscerai le mille cose di te stesso, ma piano, devi farlo
con pazienza giorno per giorno. Però questo non deve essere inteso come
un invito a temporeggiare. Devi solo soffiare sul tuo fuoco con un vento
moderato: se la fiamma è troppa, potresti bruciacchiarti. A quel punto
tutti i tuoi amici, tutte le tue migliori qualità si schiereranno
attorno a te come attorno a una fibbia per i capelli. Procurati quella
febbre che farà di te un eterna malato con la sofferenza di mai poter
abbracciare l’infinito corpo dell’amata/o. Alla fine esso non sarà più
il tuo fervore, ma il fervore, il Suo fervore. Perché sappilo, i 64
esagrammi sono tutti suoi aspetti. Ecco quindi come in fine il tuo
fervore è cieco: non vedrai più col tuo occhio ma col suo. La tua
cecità sarà molto diversa da quella di chi ha l’occhio e non vede: tu
sentirai, per la prima volta nella tua vita, con l’occhio. E’ con il
cuore che vedrai, e la tua vista non avrà limiti”.
Berescit era sbalordito, perché guardando l’orologio aveva notato che
era passata un’ora di tempo, un’ora di un magico eterno mutamento, nato
da alcune domande già gravide di ogni risposta. Non c’erano dubbi, il
“chiedete e vi sarà dato” era verità assoluta. Il tutto era accaduto
mentre la eterna tempesta della vita imperversava.
“L’acciaio va temperato” si disse Berescit, e, mentre lo diceva, si
sentiva come una spada incandescente immersa nell’acqua. L’acqua era
oltre il punto posto dopo l’ultima parola che aveva detto:
quella .
Grazie. N.
17 – IL SEGUIRE
“Non molto distante
da qui — disse Centui a Berescit — vi è un bosco di pini che emana un
profumo d’incenso che a volta il vento ci porta. Lì, a metà montagna,
in una tenda abita la vecchia Sui. Ha per compagni un leone e un
agnello. Nonostante non se ne conosca l’età, ha conservata un’intatta
incredibile strana bellezza.
L’ho incontrata circa un anno fa, e sono rimasto affascinato oltre che
dalla sua persona, dalle sue infuocate parole. Vacci Berescit; devi
conoscerla. Sai, i mondi sono popolati da tanti, ma tanti saggi, e
lasciarsene sfuggire uno solo è cosa gravissima.
Quando i fiori sbocciano e profumano, gridano. Il loro profumo è la voce
della loro anima, la cui bellezza è poco paragonabile alla bellezza dei
loro petali e dei loro colori. Col profumo, l’anima del fiore ti
penetra, ti conquista, e facendolo lascia che tu profumi per qualche
attimo. Quando mi sono trovato davanti a Sui ho “visto” tutto
questo: era un fiore, e dai suoi occhi emanava un profumo che era “mio”.
Se vuoi vedere gli occhi di un fiore, vai. La troverai facilmente perché
il profumo d’incenso viene da lei. Non puoi sbagliarti.”
Centui era un amico di Berescit, uno dei suoi 64 amici. Non lo vedeva da
anni, e quella mattina l’aveva incontrato per caso mentre passeggiava
nel bosco di querce.
L’aria era ancora fresca ed il canto degli uccelli era quello del
mattino: accordi e passaggi di prova, brevi e in sordina, dettati dal
rinnovato giornaliero stupore per il mondo. Un vento leggero allungava
aromi d’incenso in un sottile filo d’Arianna che in breve condusse
Berescit alla capanna.
Davanti ad essa, seduta su una roccia dai bagliori dorati vi era una
donna vestita di rosa. Era Sui.
Di lontano pareva una statua, perché era immobile e con le braccia
allargate ad angolo acuto in basso. Pareva salutasse il sole. Un
cordoncino le stringeva la veste alla vita.
Appena vide Berescit fece un inchino e attese che si avvicinasse.
“Benvenuto — gli disse — ti ringrazio di darmi l’opportunità di cantare.
Sai, non parlo mai, ma se qualcuno mi viene a trovare gli parlo, e
parlando mi pare di cantare. Ogni cosa profuma di eterno appena si
manifesta ad uno dei sensi. Quando ho visto il sentiero animarsi di te,
ho avvertito il profumo del Tutto in maniera più forte. Non ti dispiace
se parlo un po’, vero?” ed attese una risposta con un sorriso pieno di
gioia.
Berescit era rimasto a guardarla affascinato: com’era bella! Era una
strana bellissima vecchia dallo sguardo profumato, che mostrava l’anima
da tutta la persona, ma soprattutto dagli occhi gioiosi e teneri. Le
sue parole erano state un caloroso affettuoso abbraccio.
“Perché ti voglio bene tanto — disse il ragazzo — nonostante ti conosco
da un solo minuto?”
“Perché io ti voglio bene. Sai, l’amore per il solo fatto di essere….
vuol bene. Non posso non volerlo, sono “costretta” a voler bene a tutti.
Vedi quella sorgente? perché credi che versi continuamente acqua fresca?
E’ amore. Non la dà a nessuno: sta solo dilagando. L’amore è dentro
ognuno di noi ma è legato da pesanti catene, perché lo si vuole tenere
vicino ad ogni senso, ben stretto: più vicino è e più si sente. E invece
no, non è così. Se un giorno riuscirai a spezzare le catene che lo
legano ai sensi, esso fluirà come una sorgente e inonderà ogni cosa.
Sarà, allora, come una donna che bussa alla porta della comare per
raccontarle un lieto evento; e la comare busserà dopo alla porta della
vicina, e la vicina busserà… fino a che tutto il paese uscirà fuori. Tu
mi ami, perché io amo.
Non è un dare, ma uno sciogliersi nel tutto, un essere l’altro,
Quello... Se vi è un dare, da qualche parte scatterà l’aspettativa
dell’avere; e ciò equivale a catene. Senti come il canto degli
uccelletti esplode e si spande? Ti accorgi di come tutta la natura in
quest’ora fatata si sciolga come ghiaccio ai raggi di un sole che non va
da nessuna parte pur spandendosi dappertutto?
Il Tutto è un infinito fiore che profuma ad ogni mutamento: laddove
esplode qualcosa, una nota si scaglia nel tutto, o se preferisci, nel
nulla. Il Tutto è Uno quando nessuna sua parte esiste per se', e quindi
quando il nulla ha inghiottito la parte. Tutto questo è perdersi,
espandersi.
Sii come un fiore. E’ tutto qui, sai”
Berescit la guardava e pensava: “Quando un fiore si schiude e profuma, è
l’amore a profumare. E’ come se tutto l’amore del mondo, per celebrare
il suo dischiudersi, si precipitasse su di lui e lo arricchisse di
profumo, e lui per profonda gratitudine lo indicasse al mondo attraverso
i petali e i colori”.
“Parlami di te, amata Sui — disse — voglio conoscere la tua vita”.
“Mi stai offrendo un’altra opportunità per cantare, per celebrare la
Vita — disse sorridendo —. Ero appena una bambina quando fui condotta
dal vecchio del villaggio. Nel paese dove abitavo, tutti i bambini,
compiuta l’età di dieci anni, venivano accompagnati da lui. La stessa
cosa accadeva al compimento del quindicesimo anno di età. Era un vecchio
saggio che ad ogni bambino assegnava una parola: si chinava su di lui e
gliela suggeriva all’orecchio.
A me quel giorno sussurrò: "SEGUILO!"
Durante la prima settimana non feci altro che ripetere quella parola per
tutto il giorno. La seconda settimana cominciai a ripeterla nel sonno.
Per un mese intero ne fui ossessionata. Decisi di abbandonarla,
dimenticarla. ma non fu facile: ogni cosa che mi succedeva mi richiamava
alla mente la parola: un “seguilo” riaffiorava prepotentemente.
Se mi assaliva un desiderio di correre, la parola esplodeva. Se mi
veniva sonno, la stessa cosa: “seguilo!”. Se mi arrabbiavo, lo
stesso. Un giorno mi arrabbiai moltissimo, e come al solito, la parola
esplose: “seguilo!” Automaticamente, senza nemmeno rendermi
conto, seguii la mia rabbia, ne seguii le tracce, la rincorsi fin dentro
le parti più nascoste di me. Feci lo stesso con altri sentimenti, e
continuai a farlo per giorni, settimane, mesi, anni.
Fu così che piano piano, seguendo ogni moto interiore, riuscii ad
avvicinarmi sempre più alla sorgente del mio essere. Alla fine conclusi
che, a sentire tutte quelle cose era sempre lo stesso identico
padrone. Dai 14 ai 15 anni quindi realizzai che in me vi era un padrone
molto esigente. Ma prima che compissi 15 anni mi feci una domanda
fondamentale: “chi è — mi dissi — che si è accorto di avere un
padrone?” Ebbene in quell’attimo mi esplose letteralmente un
sorriso.
Qualche settimana dopo fui riportata dal vecchio. Gli baciai le mani e
stavo per chinarmi ai suoi piedi, ma lui mettendomi le mani sulla testa
mi disse: “Da oggi tu ti chiamerai SUI, che vuol dire il Seguire. Il
Seguire ha sublime riuscita. Propizia è perseveranza. Nessuna macchia.
Quando nasce un sorriso, nasce un amore, ma, prima o poi, quello che è
nato morirà. Quando un sorriso accade, un fiore sboccia, ma in quel
caso, la morte non ne ghermirà mai il profumo, perché i petali, prima di
lasciarsi andare giù in terra, avranno ridato al cielo tutto il profumo
che avevano. Quel fiore non morirà mai, perché un profumo, un amore, lo
sbocciare, è un segnale d’amore infinito che un fiore ha raccolto e
trasmesso.”
Era un vecchio eccezionale: aveva gli occhi profumati, e la sua persona
odorava d’incenso”.
Berescit, sorrise, annusò l’aria, fece un inchino, e mentre il sole era
alto nel cielo, guadagnò la foresta...
18 – L’EMENDAMENTO
DELLE COSE GUASTE
“La parola — disse Berescit — sia essa scritta che parlata, è
scatenante”.
E poi tacque. Tacque perché rileggendo la frase “Ku l’Emendamento delle
cose guaste”, ebbe una strana impressione: quelle parole erano come una
macchina fotografica, e lui era una montagna, una montagna volante…
… Era una strana montagne ricca di bagliori dorati e la cui forma era
cangiante, come se una gigantesca mano la modellasse dall’interno.
Volava altissima nel cielo, e le sue ali erano di vento. Aveva
attraversato dei deserti immensi per tre lunghi giorni!. Era finalmente
giunto alla fine di essi e, quando si fermò, una sconfinata distesa
d’acqua apparve ai suoi occhi. “Che strano - disse - guardo quelle acque
e perdo ogni consistenza, come se il mio sguardo, seguendo la sua
traiettoria, facesse precipitare la mia portentosa forma nell’umido
elemento. Devo stare ben attento, perché l’I Ching propone spesso questo
tipo di giochini: quando meno te l’aspetti, muta il mutamento. Come
dire, prima ti offre una tazza di tè, e mentre la stai per bere, te la
toglie da sotto il naso, così, per gioco”.
Improvvisamente una strana voce echeggiò: “Benvenuto alle grandi acque.
Qui sei al punto zero: il tuo passato è tre giorni: il primo giorno si
sente, il secondo si conosce, il terzo giorno si è. Adesso tu sei, sei
il monte portato dal vento; ma sei pure l’acqua”. Berescit, la montagna,
a questo punto non seppe resistere a una forza gravitazionale
fortissima: attraverso il suo sguardo, il monte fu risucchiato dalle
acque. Quando giunse in prossimità di esse, fu cosciente della vera
natura del proprio corpo: era un delfino. Ma una sensazione lo
caratterizzava: sentiva, dentro di sè, una mano che lo modellava e che
lo spingeva alla corsa e al gioco. E giocava correndo sott’acqua per
riemergere più in là con un bel tuffo acrobatico. Il suo corpo era caldo
e felice perché sentiva chiaro il moto della forza che da dentro 1o
scuoteva. Correva già da un’ora, quando improvvisamente incontrò lo
squalo Lorenzo:
“Ti ricordi di me? di quel giorno che m’hai dato una spinta e stavo
quasi per cadere?” “Mi ricordo sì di te. Eri venuto a casa nostra per
riprenderti tuo figlio, ma quando arrivasti incontrasti sua “madre”. Ti
ho spinto, perché tu, forse per gioco, hai spinto, ma se questo ti ha
creato problemi ti prego di perdonarmi. Anzi, se ciò può alleviarti un
pò, ti prego di ridarmi, ora qui, una spintarella, ma, per favore, fallo
per gioco e non per vendetta, se no domani qualcuno potrà nuovamente
spingerti. E poi un consiglio: i figli a una certa età vanno lasciati
liberi. Adesso ti lascio dopo averti manifestato tutto il mio affetto”.
Gli dette un amichevole colpo di coda sulla pinna dorsale e andò
dicendo: “Non stare nell’acqua per sempre; a soli tre giorni da qui vi
sono le spiagge di sabbia bianca. E’ lì che io vado”. E andò. Ma dopo un
pò di corsa e di salti incontrò un vecchio che appena lo vide gli disse:
“Non essere triste per quello che fu: ogni cosa è un giro di ruota. Se
quello che hai fatto ti ha fatto un po’ andare, non essere triste,
perché ho portato dei pesi anche per te e per voi tutti: è stata una
scelta assai ripagata da luce infinita. Adesso sto in acqua perché tu
sei qui, e tu sei qui, perché io sto in acqua, ma in appena tre giorni
sarai all’asciutto, delfino mio”. A Berescit scappò l’unica lacrima che
aveva, ma per fortuna, in acqua la cosa rimase inosservata. Andò.
Correva già da un bel pò quando incontrò una colonia di ostriche: “Buon
giorno a voi danzatrici delle acque, quali onde vi conducono da queste
parti?”
Disse la regina di esse: “Siamo compagne di viaggio e siamo venute a
salutarti perché stai per attraversare metà delle acque. Ti siamo tutte
grate e ti offriamo, in segno di affetto, queste perle” e gli misero sul
muso una bellissima collana di perle. Il delfino corse via felice.
Rimaneva ancora un giorno e mezzo di viaggio. Accelerò la sua corsa e dl
conseguenza aumentò l’altezza dei suoi salti fuori dalle acque.
Per tutta la giornata non incontrò nessuno. Alla fine del terzo ed
ultimo giorno si imbatté in quattordici tartarughe sedute in cerchio
attorno ad un tavolo: “Come vedi siamo tutte a casa. Perché non ti fermi
per prepararti un bel guscio?”
“A me piace giocare, correre, saltare. Sto per lasciare le acqua. Perché
siete qui?”
“Siamo qui — disse una di loro — perché tu stai qui, ti diamo
un’occhiata, ti seguiamo perché non sappiamo mai quello che puoi
combinare. Adesso ti scorteremo fino alle spiagge di sabbia bianca, e
poi…., beh, poi vedremo”.
Il delfino, scortato da quattordici tartarughe, riprese la sua corsa e i
suoi salti. Era contento.
Un’ora dopo, quando spiccò l’ultimo salto insieme con le tartarughe, uno
stormo di quindici gabbiani volò alto su una spiaggia di sabbie
bianche”’.
“La parola —
disse Berescit — è proprio scatenante. E’ molto meglio tacere:
Etsaug esoc elled otnemadneme’l – Uk – 81 : CLICK!
(guaste cose delle l’emendamento – Ku- 18 : CLICK!
19 – L’AVVICINAMENTO (I)
Berescit rimase immobile
davanti alla grotta. Mai nessuno aveva visto il viso di Tuikunn, ma per
tutti era come un oracolo: ci si recava su in montagna, ci si metteva
davanti all’ingresso del suo rifugio, si offriva qualche frutto
ponendolo lì nel cestino delle offerte, e poi si formulava la domanda a
voce alta.
Berescit aveva fatto tutto questo, quindi aveva pronunciato ad alta
voce: “l’Avvicinamento”, e la voce cavernosa di Tuikunn non s’era fatta
attendere: “Avvicinarsi a Lui attraverso l’altrui avvicinamento è come
guidare l’automobile guardando solo nello specchietto retrovisore.
Guarda dove metti i piedi!
Il Testo sacro è un dipinto che dapprima stimola il gusto del dipingere
e dopo “costringe” a farlo. Chi si limita a “osservarlo” è come un
affamato che osserva il piatto di pasta. Il Creativo nutre, i pennelli
colorano, i maccheroni riempiono la pancia. Salta!” e, dopo un attimo di
silenzio... “ma rimanendo là dove sei. Stattene fermo, più fermo che
puoi, ed il salto avviene”. Ancora un attimo di silenzio, durante il
quale Berescit non poté fare a meno di esclamare: “Ma chi salta?”. Era
un chiedere a se stesso, ma a Tuikunn non importava: a chi pronunciava
qualcosa davanti “casa” sua dava sempre una risposta: “non salta
proprio nessuno, eppure avviene un salto”.
Nella mente del ragazzo si stampò l’immagine di un’onda che pur
“saltando” a causa del vento rimane pur sempre un pezzo del mare, il
mare. E poi l’immagine di miliardi di atomi che pur muovendosi ognuno
per conto proprio alla fine andavano a formare un corpo, il suo, che
aveva deciso di passeggiare davanti a quella grotta e di riflettere
sulle parole del vecchio: io me ne sto qui - si disse - con tutta la mia
illusoria folla di ego (mille onde) e Lui (il Mare) mi contiene
pazientemente e amorevolmente, ignorando quasi questa mia apparente
individualità frazionata. Ma come fa un’onda a smettere di credersi
altro dall’oceano?... Che sciocco! E’ semplice: vive la sua vita di onda
senza disperarsi del fatto di essere un giorno nata, di essere dopo
cresciuta e di essere infine morta. Il mio corpo è una piccola onda
terrestre, i miei sentimenti sono una piccola onda dell’aria, i miei
pensieri una piccola onda dell’etere, la mia totalità un’onda
infinitesimale dell’universo che essa riesce a concepire quale
totalità, quale “oceano macrocosmico”. Onde su onde, movimenti
incessanti di parti di un unico corpo, UN UNICO CORPO. Come potrebbe una
mano sperare, solo sperare, di avvicinarsi al corpo che la alimenta?
Come può un piede avvicinarsi al corpo di cui è parte inscindibile? Ecco
perché l’avvicinamento è un saltare da fermi e senza muoversi: esso è
uno SCIOGLIERSI, un saltare in quel incredibile sconfinato anonimato.
Nella mente di Berescit continuavano a stamparsi immagini su immagini.
Adesso era la volta di una grande orchestra: la sentì chiaramente
suonare e si disse: “se quel violino ignorasse il resto dell’orchestra e
si mettesse a suonare più forte degli altri, e se il trombone e il
violoncello e tutti gli altri strumenti facessero lo stesso, non
sarebbe possibile produrre quell' anonimo incredibile impasto di suoni.
Se lo zucchero volesse continuare a essere tale, e l’amido e il latte
ed il fuoco ed il cacao volessero ognuno rimanere se stesso, il budino
non “avverrebbe” mai. SCIOGLIERSI, amare ogni cosa, fare in modo che il
mio essere sia solo una piccola insignificante nota che contribuisce a
far si che la sinfonia si manifesti. Se lo zucchero, improvvisamente,
pensasse di rimanere tale e quale è, lì nel budino, non tutte le parti
del budino sarebbero dolci: sarebbe una stonatura, sarebbe un salto sì,
ma della mente.
Occorre umiltà. Ma per essere umili occorre coraggio, la più alta dose
di coraggio possibile. E’ l’umiltà non del sentimentale che guardandosi
dopo allo… specchio della gente dirà “o Dio come sono umile!”, ma quella
dell’amato/a per l’amata/o: lo sciogliersi che dà origine al Noi, quel
Noi che nasce, avviene quando un io e un tu si uniscono davvero.
Qualcuno lo chiama Amore, ed è giusto. Poi vi è lo sciogliersi di un io
e un voi che dà origine al NOI. Qualcun altro chiama questo AMORE, ed è
vero.
Quando avvengono queste unioni il violino, pur cantando l’assolo, tace;
quando ciò avviene, ogni strumento, pur suonando, smette di essere uno
strumento che suona: è il tutto che suona, è l’orchestra”.
Berescit pensava così, quando improvvisamente sentì la voce del vecchio
Tuikunn tuonare dalla grotta: “Adesso, ragazzo, volta pagina perché
l’orchestra è una nota, un’umile nota del coro d’orchestre, e dopo
questo coro d’orchestre sarà pur sempre un’umilissima nota del coro del
coro...
Ti dico in confidenza questo: sarebbe meglio che tu non dicessi niente,
che tacessi, che non suonassi nemmeno una nota; ed allora entreresti nel
regno del silenzio e con te sarei costretto ad entrare anch’io. Taci
dunque!” Berescit tacque e smise di passeggiare davanti a quella grotta.
Rimase per un po’ immobile, e quando ogni suo senso si sciolse,
un’orchestra di silenzi prese a suonare più alti silenzi.
A quel punto il ragazzo scosse la testa come fa il cane uscito
dall’acqua , e a voce alta disse: “Il budino non è ancora pronto, sarà
pronto nel venti: la Contemplazione”.
Esagrammi su esagrammi, ecc. ecc.
19 – L’AVVICINAMENTO (II)
Nel bel mezzo
dell’isola del fuoco, fra le pianure di Egon e Segon, la città di legno
mostrava tutte le sue cortecce
al sole cocente del mezzodì.
Quel giorno, grazie
all’aiuto dei quattro perfetti, Berescit e Shekinà vi erano giunti dopo
un lungo e avventuroso viaggio.
Dalla parte della
pianura di Egon, nella parte bassa di un esteso massiccio montuoso che
la limitava, un’enorme distesa levigata di marmi rifletteva una schiera
di combattenti che credeva di vedere nell’immagine riflessa un esercito
nemico. La paura li teneva inchiodati là: erano secoli che si
fronteggiavano.
Dal lato opposto,
dalla parte della pianura di Segon, un infinito silenzio era la voce
costante dell’Uno: ogni cosa ed ogni essere era consapevole di sè e del
fatto che lì non erano in tanti, ma Uno. Ogni cosa era vera, viva.
La città di legno era
abitata da un solo uomo, Tloì, e da 1.000 Paròm. I Paròm erano degli
uomini-tempo, la cui età media variava fra i pochi secondi e i tre anni.
Ovviamente comandava Tloì, ma quando i Paròm si riunivano e decidevano
di operare in massa, divenivano potenti, anche se molti, a causa della
loro breve esistenza, si dissolvevano sotto gli occhi degli altri più
longevi. In effetti i Paròm erano figli di Tloì, dei figli indesiderati.
Durante gli anni della sua giovinezza egli aveva giocato un po’ troppo
con la sua mente e con essa era riuscito a creare un vero e proprio
popolo di esseri dall’aspetto quasi umano.
Ora avvenne che un
giorno Tloì se ne stava ai confini della propria mente quando vide nel
cielo del suo mondo due punti di luce che avvicinandoglisi, diventavano
sempre più luminosi.
Adesso la città era
lì, avvolta da queste luci dentro un infinito spazio mentale. I Paròm
cominciarono a lasciare ciascuno la propria abitazione e piano piano
andava formandosi una gran folla: insieme si sentivano più sicuri di
fronte alla minaccia delle avanzanti luci, le quali, poco dopo,
assunsero l’aspetto di due esseri solari.
Tloì rimase
affascinato dalla bellezza e dalla potenza che emanava dal loro essere:
“Noi — dissero — siamo i tuoi due veri figli. Quella folla di apparenze
vorrebbe possedere la nostra essenza per essere forte, ma nello stesso
tempo non riesce a sopportare la nostra vista. Fra poco si avventeranno
famelici, ma non saremo noi a dover soffrire: tu lotterai, perché noi e
loro insieme, in te non possiamo convivere. In passato hai creato
proprio un esercito agguerrito e adesso, in questo momento, ora che hai
attirato noi nella tua orbita sarai attaccato dai tuoi stessi mercenari.
Quei tuoi fantocci potremmo finirli uno a uno, ma siccome sono una
folla, fra poco diventeranno un unico grosso essere. Solo allora noi li
combatteremo. Quando tu ci hai attirati qui, con i tuoi occhi hai
costruito un ponte sull’abisso: una strada di fuoco collega adesso te a
Quello. Ma le vere artefici di questa tua realizzazione sono le tue
ultime nate: esse non sono figlie della mente ma del cuore. Una è Gnosài,
l’altra si chiama Eroìs. Anche se tu, adesso, le sacrificassi per noi,
anche se le dessi in mano alla folla per rinsavirla, non risolveresti il
problema: quella gente va eliminata, bruciata, perché tu ci hai accolti
in te e ci hai preparato da mangiare un alimento che mancherà a loro;
ecco quindi come necessariamente noi vivremo e loro dovranno morire”.
Improvvisamente la
folla divenne un grosso drago nero dalle ali approssimative. Sputava
fuoco e dimenava una lunga coda e volava minaccioso sopra la città di
legno.
I due esseri luminosi
si scagliarono alti nel cielo come due meteore. Il drago lì seguì, ma le
due sfere di fuoco invertendo improvvisamente direzione si conficcarono
nei suoi occhi facendolo esplodere. Una massa di fuoco precipitò sulla
città di legno provocandone l’incendio.
La vecchia città poco
dopo divenne una landa di cenere che faceva di due pianure un’immensa
spianata, mentre il massiccio montuoso con la sua distesa di marmi
levigati precipitava in una voragine con tutta la schiera di vecchi
guerrieri.
Una scala di luce
collegò quel punto al cielo, mentre la voce dei due esseri luminosi
diceva: “Sali, ma non andare altissimo: ogni città è le valle di quella
seguenti. Non voltarti mai indietro per la fine che folle di apparenze
faranno. Abbi cura della tua discendenza, fai così: inebriati di vero e
lasciati vivere dalle tue figlie Gnosai ed Erois. Stai or con l’una or
con l’altra, riempiti di loro, fatti da loro riempire”.
La scala scomparve ed
al suo posto apparve un’enorme distesa di girasoli che, in poco tempo,
riempì l’oramai unica pianura, la pianura di Es. Al centro della
sconfinata distesa di girasoli vi era una quercia secolare il cui tronco
era d’oro ed i cui rami brillavano come diamanti al sole.
Un assordante ronzio
attirò l’attenzione di Berescit e Shekinà: milioni di milioni di
insetti, volteggiando sui girasoli, parlavano ronzando: “Salute a voi
conoscitori; la pace del luogo santo vi riempia fino alle stelle”.
“Chi siete?”.
“Noi siamo la storia
— disse il ronzio, mentre lo sciame d’insetti assumeva la forma di
aquila — siamo la storia che avete appena ascoltato; siamo una penna che
scrive, un’immagine mentale, un fiore, un albero; siamo Tloì, Parom;
siamo il silenzio. Siamo tutto quello che c’è e tutto ciò che non c’è;
quello che fu e quello che sarà. Siamo quello che non sarà mai. Noi
siamo colui che gioca con noi; siamo l’eterna certezza dell’essere
eterno; siamo l’aquila bianca, una quercia, l’antica città. Noi siamo
persino le prossime frasi a noi sconosciute: è il gioco più bello del
mondo. Il nostro ronzio vi ha raccontato e fatto vedere il mistero del
centro più basso, allorché da lì la corrente sale alta verso la vera
città, verso la Gerusalemme di luce che accoglie Israele. Siamo la
vista di ogni cosa, un occhio infinito. Quel campo di girasoli non
finirà mai di sbocciare, come mai finirà il nostro ronzio, perché oggi
ve lo porgiamo sbattendo le ali, domani ve lo passeremo in un cane che
abbaia oppure in un uomo qualunque. Noi siamo la musica nascosta in Tloì,
le penne dell’aquila bianca, il vostro ascoltare, il nostro ronzare.
Salute a voi
conoscitori. La pace del luogo santo vi riempia fino alle ossa per
sempre. Possa la pelle che con amore vi avvolge lasciarvi passare.
Possiate andare oltre l’involucro santo per essere aquile sante.
Possiate voi essere fuori al più presto, ma non con il corpo leggero per
mondi leggeri. Possiate essere l’eterno infinito che in voi, da voi, per
voi guarda le infinite forme di Se stesso. Che bisogno c’è di portar
dentro tutto quello che è fuori? Non esiste ascia che possa spaccare il
legno dell’Uno”.
E si posarono tutti
insieme sul campo di girasoli in una pioggia di ali.
20 LA CONTEMPLAZIONE
La tenda del principe Mailì
era stata piantata sulle sabbie calde del deserto dei datteri mille anni
prima che nascesse suo nonno Faràl.
Erano oramai secoli che il principe abitava lì, ed aveva scelto quel
luogo perché, agli inizi del suo tempo, gli era stato detto che fra
quelle sabbie avrebbe incontrato il padri dei padri.
La tenda era preziosa perché fatta di lamine d’oro, ma in un deserto di
sabbie dorate il suo valore veniva confuso, anzi diventava
insignificante. All’interno di essa, proprio al centro, vi era però un
vero tesoro costituito da un pozzo, il pozzo infinito. L’aveva chiamato
così, perché seicento anni prima vi aveva gridato dentro e non era mai
ritornata alcuna eco: era senza fondo. In esso non vi era una sola
goccia d’acqua, eppure il principe si dissetava regolarmente, anzi
spesso, per via di una sete propria di chi è stato sfiorato dal Fuoco
Perenne; di una sete prosciugante, martellante. In esso la sua anima
riusciva a placarsi, seppure per brevi momenti.
Berescit e Scekinà dopo due giorni di volo giunsero sopra il deserto, ma
stranamente non riuscirono a scorgere una sola palma. “Perché mai — si
chiesero — viene chiamato il deserto dei datteri?” L’avrebbero chiesto
al principe Mailì al tramonto, appena cioè, col sole molto inclinato,
avrebbero potuto scorgere l’ombra della tenda.
Quando più tardi la videro, si portarono giù. Il caldo era intenso ed
era quasi impossibile tenere i piedi su quella distesa di polvere d’oro.
Si portarono sotto il parasole all’ingresso della tenda e proprio lì
videro un tavolinetto con sopra un vaso con una palma nana che portava
un solo dattero.
Pensando che era conveniente rivolgere un rispettoso saluto al principe,
i due ragazzi, volgendo la voce all’interno dissero: “Andiamo a spasso
per il mondo in cerca di santi e di grandi. Lunga vita a sua altezza,
principe Mailì. Il grande silenzio sia sempre con vostra Grazia”.
“La pace sia con voi, amici miei — rispose da dentro la voce — siate i
benvenuti in questo deserto. Accomodatevi. Sarete miei graditi ospiti
per tutto il tempo che vorrete”.
I ragazzi entrarono. Il volto del principe era buono. Due occhi grandi
in un viso abbronzantissimo. Un copricapo giallo ed una tunica gialla
con cintura rosso chiara. Sandali gialli con cuciture e lacci rossi. Ma
la cosa che più colpì Berescit e Scekinà non fu tanto la figura del
principe, quanto invece l’interno della tenda: non esistevano pareti,
niente volta. Si vedeva solo un muro di pietre non più alto di un metro
che si perdeva a sinistra e a destra.
“Molte cose qui sono strane principe Mailì — disse Berescit coinvolgendo
Scekinà che aggiunse: — intanto il nome del deserto, poi la sabbia, la
tenda, il pozzo, la tua solitudine”.
“Perché la vostra mente — miei cari — ha posto tutte queste domande? Non
vi basta esservi trovati in un posto bello come solo nelle favole vere è
possibile trovare? A che cosa vi servirà mai sapere tutte queste cose?
Quello che conta è che qui c’è un pozzo a cui tutti quelli che mi
vengono a trovare possono attingere. Non penserete di sprecare il vostro
tempo per chiedere al pozzo, vero? Vi dirò sola che quel muro là è il
parapetto del pozzo infinito: la tenda non può avere dimensione perché
contiene un pozzo senza dimensione. Non tutto quello che è limitato
all’esterno ha limiti interni: il varco che sta fra verbo e silenzio è
un “luogo” infinito, un abisso. Ma adesso vi prego di assaggiare i miei
datteri...” Raccolse il frutto, l’unico frutto che c’era e lo porse a
Scekinà. Nel momento in cui lo raccolse avvenne una cosa stranissima: un
altro dattero rispuntò nella piccola palma, e la cosa si ripeté quando
ne prese altri due, uno per Berescit e uno per sè.
“Come vedete — disse — quest’alberello porta sempre un solo frutto, ma
non si esaurisce mai. Esso mi è stato regalato dal… pozzo il giorno in
cui gli ho... (e guardò divertito i due ragazzi) giurato eterno amore”.
Aspettò la reazione dei due giovani, che dapprima contennero e poi
esplosero la loro risata: “Scusaci principe Mailì, ma la tua voglia di
ridere ci ha influenzati più delle tue parole. Sappiamo benissimo che
qui tutto è simbolo, tuttavia vorremmo che fossi tu a chiarire la cosa”.
“Vi sto solo mostrando ciò che nessuno mai ha potuto mostrare:
l’archetipo, se così si può dire, dell’anima: il pozzo, la smisurata
interiorità dell’uomo. L’anima è sorella perché è figlia dello stesso
padre mio, ma essa non è figlia di mia madre: madre natura. Essa è
direttamente nata da mio padre per precipitazione. Dapprima non la
conoscevo ed era sorella estranea; ma appena l’ho scoperta, appena lei
ha scoperto me, siamo diventati una cosa sola, la cosa unica. Adesso
siamo marito e moglie e nessuno mai potrà separarci. Ho affidato il suo
profumo, o meglio il suo profumo è stato affidato a...” e indicò con la
mano... poco più avanti comparve una donna bellissima.
“A coloro che scoprono la loro anima, è dato vederla nella loro
compagna, nella gemella, nella sorella. Ragazzi, vi presento la mia
dolce metà, il suo nome è Eh. Cosa vorreste chiedere?” e sorrise.
“Il nostro Budda s’inchina al tuo Budda, principe amico. Sarebbe bello
in questo momento levare la tenda e tutti confondersi nel tutto, per
divenire un pozzo infinito più grande del pozzo infinito. Levare la
tenda è allargare la tenda, è morire per sempre ai deserti e alle cose.
Levare la tenda è offrire all’altare se stessi. Tu principe Mailì ci hai
mostrato la radiante potenza dell’Uno che essendo solo Se stesso,
bruciando, E’. Ma essendo se stesso e girando (come una torcia ruotante)
occupa tutti gli infiniti spazi. Sapere di essere torcia e non cerchio
vuoi dire essere Budda, uno che sa di essere un puro riflesso del
fuoco”.
“Le vostre parole di fuoco — figlioli — mi fanno un gran bene. Oggi noi
leveremo le tende. Voi sarete i nuovi guardiani del pozzo infinito. Il
dattero è vostro: esso è cibo solo per chi è rinato; se un fuoco fatuo
ne raccoglie il frutto, questi non si riprodurrà più. Fatevi la vostra
tenda spaziosa e larga, e ponetela laddove c’era questa. Che la luce
infinita piova su di voi fino a sommergervi e farvi scomparire così come
noi. Adesso vi preghiamo di uscire. Addio figlioli”.
E mentre i ragazzi uscivano la voce del principe Mailì echeggiava:
“prima la tenda, qui, nel deserto. Dopo, in essa, il pozzo”.
Scomparsa la tenda, il principe, Eh ed il pozzo, nell’immensa distesa di
polvere d’oro rimasero solo due ragazzi ed una piccola palma con un solo
dattero.
Era un nuovo giorno.
21 IL MORSO CHE
SPEZZA
- Il morso è il primo atto
del processo nutritivo. Se mordi qualcosa senza spezzarne una parte, il
nutrimento non può avvenire. Ecco perché è detto il morso che spezza ha
riuscita.
- “Dar corso alla legge” vuol dire non lasciare la frase “il morso che
spezza ha riuscita”come una vuota norma scritta che tale rimane, ma
dargli corso, cioè attuarla
- In immagine ciò è reso con il tuono e il fulmine: l’uno segue sempre
l’altro L’attuazione della legge è il tuono, la legge è il fulmine.
Questo è il morso che spezza, disse Berescit all’aria che lo circondava.
Devi essere in grado di correre subito ai ripari nel caso in cui non
riesci a spezzare, cioè a nutrirti. Devi essere rigido con te stesso,
inflessibile: la legge è la legge e va necessariamente applicata. Nel
caso in cui non riesci a mordere l’esagramma e a spezzarlo in bocconi
per nutrirtene, rimarrai arido come un deserto, ingiusto come chi ignora
la legge, vuoto come una canna di bambù, sconfitto come un re
disubbidito.
Berescit tacque e cominciò a seguire il volo acrobatica di due colombi
bianchi che segnavano nel cielo delle traiettorie circolari: giravano
attorno ad un punto nello spazio come due elettroni nell’atomo.
Li seguì per un po’ in silenzio fino a quando, in picchiata, i due si
posarono ai suoi piedi:
“Siamo Sci — Ho” dissero in coro, “tu chi sei?”.
“Sono Berescit e sto consumando un pasto eccezionale. Volete farmi
compagnia e mangiare con me?”
“ Sì, dissero in coro Sci — Ho, siamo felici di accettare, nonostante
abbiamo consumato il nostro pasto attorno al punto”.
“Cos’è il punto”, chiese Berescit.
“E’ un punto qualunque dello spazio—tempo su cui dirigiamo tutto il
nostro amore: esso è il Luogo di Dio, il suo tempo, come un altare,
costringe alla essenza, manifesta la divinità. Il nostro amato girare ne
è testimonianza. Ma dì un pò, tu intorno a cosa giri, qual’è il tuo
punto?”
“Il mio punto sono vecchie parole cariche di millenni di età, attorno a
cui hanno volato i cercatori del punto dei punti. Io ho provato dapprima
a fare un pò di giri, ma, ‘creato’ il punto, mi sentivo distante da
esso, lo vedevo lontano nonostante un raggio d’amore mi legasse a ‘lui’
e mi costringesse ad una precisa orbita. Poi decisi di volarvi dentro, e
l’unico modo per farlo era quello di mangiarlo. Voi siete arrivati
mentre mi accingevo a farlo, ma... e qui non mi crederete…., la cosa più
bella è che voi due siete parte del punto come io lo sono per voi. Se
non fosse così saremmo delle cose irreali, invece siamo veri perché
consci di essere parti del punto”.
“Il tuo cibo è buonissimo e ce n’è in gran quantità. Il nostro parlare
sarà un suo nutrimento, un sapore manifesto, un canto d’amore. L’amore
non è percepibile che attraverso i suoi effetti. Ebbene, come una linea
è l’effetto di un punto che va, così la nostra parola: sarà il profumo
di un fiore, uno sguardo d’amore, un raggio di sole che va senza meta;
un morso che spezza ti spezza piano piano fino a che dimenticherai di
essere sole: mille, centomila raggi di luce ti “disperderanno” negli
infiniti spazi ed il tuo andare sarà un essere lì oltre i tuoi limiti.
Il calore andrà su qualcosa come luca. Che pranzo eccellente il nostro!”
“Invero, Sci — Ho, siete un punto del punto dei punti, una parte
spezzata da un morso che ripete se stesso nell’eterno nutrire.
Il punto dei punti, Sci — Ho, si nutre di voi perché voi vi nutrite di
esso. Dietro ogni vostra soffice penna e piuma si cela un silenzio che
spezza ogni cosa. Il morso che spezza è un silenzio infinito che
addenta la vita e si nutre di essa tradendo se stesso cantando.
Amore è la vita di un canto, il profumo di un fiore, l’essenza di ogni
illusione. Inafferrabile Amore! Una carezza non è amore, ma viene da
esso. Un fiore non è amore, ma viene da esso.
Voi, Sci — Ho, non siete la fame, ma il morso che spezza. Voi siete un
magico effetto d’amore, un cibo divino che nutre qualcosa che è amore e
che si manifesta in un corpo.
Il Regno, il Malkuth, è un morso che spezza, un raggio di luce, un
effetto d’amore, un punto, ma… non il punto dei punti.
Il sole dei soli è amore, silenzio.
Io e voi siamo un piccolo tuono di un piccolo fulmine, una piccola
immagine di un grande silenzio; un piccolo morso che spezza, Sci — Ho”’.
22 PPI – L’AVVENENZA
Quando glielo avevano
detto non ci aveva creduto, ma nel momento in cui gli fu davanti dovette
arrendersi ai fatti: il cavallo parlava.
Per incontrarlo si era spinto lì, oltre il deserto, nella foresta di
salici, in groppa al suo cammello Zuà. E fu proprio quando le scorte
d’acqua erano oramai finite da un pezzo che scorsero in lontananza
l’immensa foresta di salici, in cui si inoltrarono dopo l’ultima
faticosa marcia.
Una gradevole frescura li accolse, ma già prima di penetrarvi Berescit
si era accorto della ordinata disposizione in filari degli alberi.
In effetti, se avesse potuto vedere dall’alto, avrebbe visto come un
enorme occhio stranamente vivo, il cui centro era costituito da un
laghetto, nel mezzo del quale, da una roccia, scaturiva una sorgente
d’acqua.
I filari, dunque, erano disposti come a raggiera e Berescit, percorrendo
uno di essi insieme con il suo stanco cammello, era giunto poco dopo
alla sorgente. Bevvero abbondantemente, quindi si sdraiarono all’ombra
di un salice e si addormentarono.
Dopo alcune ore di sonno profondo, i nostri due amici furono svegliati
da una voce che pareva uscisse da una caverna: “Chi sei ragazzo? Perché
sei qui? come hai fatto a vincere il deserto?... Il mio nome è White.
Chi sei?”
“Mi chiamo Berescit, e sono qui per te, volevo vederti, parlarti. Questo
è il mio amico Zuà. E’ stata la voglia di incontrarti che mi ha fatto
vincere il deserto, ma anche la pazienza e la robustezza del mio
compagna di viaggio. Vorrei che tu mi parlassi di te, White”.
“Sappi, allora, ragazzo, che non sempre sono stato un cavallo. Tanti,
tanti anni fa ero un mercante. Esercitavo regolarmente il mio commercio
e gli affari andavano bene. Passavo le ore di riposo in famiglia fra
l’affetto dei miei cari. La mia vita trascorreva serena e normale, fino
a che, un giorno... Un giorno, un mio vecchio amico, dalla Cina mi portò
in regalo un libro, uno strano libro. Fu da allora che la mia vita
cambiò. Già appena me lo diede avvertìi come un’atmosfera di sfida
simile a quella che, bambino, provavo davanti a un compagnetto
dispettoso e prepotente. Non era un libro normale. A dire il vero, tutti
i libri contengono l’atmosfera astro-mentale dell’autore, ma in quello
c’era qualcosa di più, come se in esso fosse contenuto l’autore in carne
ed ossa; tanto che, fra lo stupore del mio amico (evidentemente lui non
avvertiva tutto questo), chiesi al libro: “chi sei?”, e subito dopo
nacque in me la risposta: aprimi e lo saprai. Aprii il libro a caso ed
a pagina 39 vidi uno strano simbolo; poi lo richiusi e ne lessi il
titolo: I KING, Il Libro dei Mutamenti. Capii subito: era come la
rappresentazione grafica di Adamo caduto con tutti i suoi aspetti. Un
Adamo da conoscere. Pensai questo, nonostante mai avessi pensato alle
cose della spirito. Ma ciò non mi impedì di vedere in esso, anzi, in
Lui, l’incarnazione del mutamento, il mutamento in persona.
Lo aprii a caso una seconda volta e lessi: PPI — L’Avvenenza. Avvenenza
ha riuscita, in piccolo è propizio imprendere qualche cosa. Rimasi
pensieroso per un pò, nella vana speranza di capire quello che mi stava
dicendo, ma ciò mi riusciva impossibile, perché era come voler far
ritornare in vita un morto: le parole da lui dette mi penetravano,
venivano da me masticate, e mutavano subito in qualcosa d’altro che mi
sfuggiva, ed il MUTAMENTO era l’unica cosa che rimaneva lì, quasi
palpabile, come l’unica, vera certezza. Ebbi l’impressione di trovarmi
di fronte ad una sottilissima sostanza mentale in continuo movimento, ad
una voce in continuo canto che ti faceva appena intuire, e non vedere,
il cantante. Ma nello stesso tempo era uno specchio che ti rimandava
tutte queste cose insieme, cioè i vari aspetti del tuo indefinibile, ma
certissimo Essere.
Da quel giorno, piano piano cominciai a perdere la mia identità mano
mano che i miei colloqui coll’I King si fecevano sempre più serrati;
come se ad ogni sprofondamento in esso, la mia mente venisse inghiottita
dal libro, il quale, nello stesso momento, mi sfidava come un essere
momentaneamente privo di mente, ma pieno di qualcosa d’indefinibile,
qualcosa che assomigliava ad un silenzio pettegolo, qualcosa di
paradossale che mi faceva vedere il mondo non con i miei occhi, ma con
gli occhi del mondo.
Più leggevo e meno mi interessavo dei miei affari, che piano piano si
spensero completamente. Poi mi allontanai anche sempre più dalla mia
famiglia, e dai miei mi sentivo sempre più spesso dire: “Sei peggio di
un cavallo selvaggio, sembri mezzo matto, fai le cose più strane come
fossi un bambino sempre intento a giocare, hai perso ogni serietà”. Ed
il guaio era che mi sentivo perfettamente come loro dicevano: un cavallo
selvaggio. Insomma mi ero completamente dimenticato di me perché mi ero
reso conto di non avere mai avuto un “me” invariabile nel tempo, e che
l’unica cosa reale e immutevole era invece il mutamento che mi
accompagnava ad ogni istante di esistenza; un mutamento che mi svuotava
di ogni illusoria apparenza e che mi lasciava sempre più pieno di
silenzio chiassoso.
Adesso, ragazzo, sono White, in questo momento sono un cavallo bianco
che sta alla sorgente della foresta di salici, ma per quanto tempo lo
sarà ancora non so, perché il libro mi incalza implacabile, inesorabile;
né vale a qualcosa chiuderlo ed ignorarlo: te lo ritroveresti in ogni
attimo di esistenza, perché il suo contenuto è anche un contenente,
il contenente. Anche tu ne fai parte.”
“Dimmi White, c’è un ultima mutamento?”, chiese Berescit.
“La gente, figliolo, confonde spesso il Tao con la manifestazione di
esso.
Il Tao è il non mutamento, questo.
23 - LO SGRETOLAMENTO
Quella mattina,
Berescit si trovò davanti a una strana porta.
Le due ante di legno erano costituite da cinque tavole parallele sospese
nel nulla, e da una sesta in alto da architrave.
Un senso di paura gli impediva di entrare, perché aldilà di essa vi era
il vuoto, il nulla assoluto, e chi avesse varcato quella soglia si
sarebbe annientato, sgretolato in essa. Né era da prendere in
considerazione la vocina interiore che gli suggeriva di considerare la
cosa come scala anziché porta: in che modo avrebbe potuto scalarla, se
tutti i pioli erano segati a metà? Senza considerare il fatto che, ante
o pioli, il problema fondamentale rimaneva: la struttura non aveva
alcuna solidità.
Berescit ignorò anche la voce di Pat, la quale, come un pungolo, lo
spingeva: “Se non entri o non sali in qualche modo, non lo penetri, e
perdi la sfida”.
Non gli importava niente di niente. Stette in attesa….
Finalmente una prima idea lo assalì: bastava aggiungere un piolo (che
avrebbe potuto chiamare “piolo della misericordia”) lì in basso, e la
cosa era fatta. Ma la voce di Pat lo scoraggiò subito: “Sconfitto!” Ma
sconfitto da chi, da cosa, perché? E poi, cosa avrebbe mai potuto
vincere? Ogni vittoria presuppone un nemico o comunque un concorrente,
quindi fatti e non chiacchiere.
Una seconda idea gli balenò: fatti nulla e osserva la cosa da lì. Ma
ancora una volta la vocina sorniona di Pat: “Lì... dove?”.
Seguì un gran silenzio che tuttavia non era “nulla”: c’era qualcosa che
rendeva la vicenda percettibile, e cioè l’attesa di ciò che avrebbe
trasformato nel nulla il silenzio, vale a dire quel tipo di morte che fa
vero uomo l’essenza del cadavere. Alcuni, pensò Berescit, riescono a
sorridere da morti mentre sono in vita. Da lì il passo per una nuova
massima fu breve: i vivi non morti piangono; i morti vivi sorridono.
Quest’ultima idea gli parve buona. Rimase così in attesa.
Quando, poco dopo, l’attesa finì, cominciò il nulla; ma cominciarono
pure i guai per il nostro Berescit: non vide più la porta: tutta
l’apparenza dell’essere, trasformandosi in quella porta, assorbì ogni
mondo, ogni universo, ogni altro aspetto, e per burla parlò a se stessa:
sono un aspetto e m’aspetto di tutto. Ma echeggiò subito una risata, la
sua, perché, esistendo solo essa, sapeva benissimo di non potersi
aspettare niente al di fuori di se'.
Era proprio un’idea da scartare…
Altra idea:
La cosa in se stessa è in sgretolamento e comincia a vivere la sua
parte per noi qui ed ora: il sogno ad occhi aperti che ci fa vivere il
segno comincia ad essere sgretolato dalla interpretazione che di esso si
sta facendo: le prime parole sono gli inferiori su cui poggeranno le
parole e le immagini successive; i perseveranti vengono annientati, cioè
le cose dette vengono “finite” dicendole (ad ogni nascita corrisponde
una morte); ecco perché sciagura: da ogni inizio parte una fine che lo
stesso inizio rincorre fino a confondersi in essa e scomparire. E più se
ne parla, più il letto (il sogno) la cosa, viene sgretolata; anzi si
sgretola perché trattasi di un sogno che interpreta un sogno.
Qui Berescit fece una pausa di riflessione, e senza accorgersene,
pensando ad un suo personale impegno per il pomeriggio, stava dando vita
alla terza variante: egli si sgretola da essi, nessuna macchia.
Ma subito dopo venne riassorbito dal sogno e si sentì accapponare la
pelle: il sognatore stava per essere attaccato dal sogno per essere
assorbito e sgretolato. Questa volta toccò con mano la sua “sciagura” in
itinere.
Il sogno stava cominciando a dare i numeri..., ma no, è semplice, si
disse: i sensi (le dame di palazzo) seppure senza coinvolgimento,
riprendono il sopravvento sulla schiera di muti pensieri (i pesci).
Tutto è propizio: nonostante la cosa si stia inesorabilmente
sgretolando, si apprende ancora una volta l’eterna lezione della vita:
sotto il cielo tutto è caduco. Qui, l’esagramma resiste ancora (linea
intera: un grosso frutto non ancora mangiato), vi è qualcosa da
sgretolare: è il futuro (linea intera che sta per essere spezzata dal
basso) ancora da vivere. La carrozza del nobile è il tempo che il
sognatore ha ancora a disposizione per percorrere l’ultimo tratto di
sogno. E’ proprio qui nella sesta linea che sta il nocciolo del
problema: il nobile, se saprà vivere lo sgretolamento, otterrà qualcosa
in premio (l’esagramma 24); mentre l’ignobile, non sapendolo vivere,
assisterà alla lacerazione della sesta linea da parte di una forza che
viene dall’alto; come se qualcuno lo colpisse da sopra.
Lo sgretolamento si era dapprima presentato, dopo aveva recitato la sua
parte servendosi di Berescit; ed infine era rientrato nel silenzio
assumendo l’aspetto di una pausa musicale in quella divina sinfonia che
è la vita scritta sulla partitura dell’I Ching.
Berescit aveva ancora una volta tentato di afferrare il Direttore
d’orchestra, ma si era reso conto di essere ricaduto nel solito
paradosso di chi lancia il grido e poi lo rincorre per riacchiapparlo.
A questo punto non gli rimaneva che cantare:
Lo sgretolamento mi
ha sgretolato,
eppure rimango.
Un attimo fa non ero
chi parla:
è morto qualcuno che
ero;
eppure rimango.
Lo sgretolamento mi
ha solo sfiorato la pelle,
come un odio
innocente—incosciente
accarezza chi ama
l’odiante.
Chi ero un attimo fa?
una foglia caduta;
eppure rimango.
Ogni istante è
primavera e autunno:
foglie che vengono e
vanno sull’albero eterno.
Cos’è che rimane di
me seppure mi sgretola il tempo?
Cos’è che s’espande
di me seppure mi scioglie lo spazio?
Cos’è quel sole che
immoto mi vede girare, e mi gioca
e osserva da ogni mio
senso? cos’è che non tocca l’I Ching?
Chi è che gioca
muovendo esagrammi che muovono me?
Lo Sgretolamento mi
tocca, eppure rimango.
E quando dai sensi
del corpo nessuno mai più guarderà,
verranno altri occhi,
altri sensi,
per sgretolamenti su
sgretolamenti...
Eppure…. Rimango.
23 - LO SGRETOLAMENTO
BREVE DIALOGO FRA DUE SORDI
Entrano due strani personaggi
ciascuno con un libro rosso in mano ed una cuffia alle orecchie. In
scena vi sono solo due sedie. Una musichetta ironica accompagna il loro
strano modo di fare; appena entrati posano il libro sulla sedia e
ciascuno butta in aria una sola moneta. Dopo ogni lancio, ciascuno va
alla lavagna in fondo alla scena per tracciarvi una linea senza senso
(un pò curva, un pò ondulata) per poi andare ad aprire a caso il libro
rosso e leggere l’uno all’altro.
1° lancio: A compie tutte le operazioni descritte e poi aprendo il libro
a pagina 141 (nove sopra) “Ecco un grosso frutto non ancora mangiato. Il
nobile riceve una carrozza. All’ignobile si sgretola la sua casa.”
(Fissa l’altro e gli dice in maniera più marcata): Ho la sensazione di
avere un vaso pieno di fiori e non poterlo poggiare su nessun piano.
Oppure avere una pera, ma non poterla mangiare per mancanza di denti.
Oppure ancora, come se avessi una gran voglia di correre e non poterlo
fare poiché mi manca la strada sotto i piedi (mima una corsa da fermo
con due, tre alzate di ginocchia).
Poi si ferma, raccoglie la monetina, prende in mano il libro rosso e si
siede tacendo. Quindi si alza B. Fa le stesse operazioni di A e poi apre
il libro a pag. 141 (sei al quinto posto) legge:“Una schiera di pesci.
Mercè le dame di palazzo viene favore. Tutto è propizio.”
Sono un delfino in cerca del1’onda. Poi sono un’onda in cerca di una
costa. Quindi sono una spiaggia in cerca di mare. (Pausa) ...mi sono
perduto!
Ma… tu… mi vedi?
Ovviamente ognuno non sente l’altro e pertanto ignora l’altro.
Dopo un paio di lanci (sei all’inizio e sei al terzo posto):
A: sono un letto. Dimmi, come fa un letto a dormire? se gli si
sgretolano le gambe? Tu come fai a dormire se non sei un letto?
B: mi sento metà di qualcosa, ma cosa?
Entra C, toglie le cuffie prima ad A e gli sussurra qualcosa, poi lo
stesso fa con B. Quindi toglie loro le monete, ne aggiunge una sua e le
lancia sei volte. Va alla lavagna, cancella tutti gli scarabocchi, e vi
disegna mano mano due trigrammi. Dopo ogni trigramma che rappresenta un
personaggio (A e B) i due personaggi fanno un inchino di presentazione
al pubblico.
Finalmente i due si stringono la mano.
24 - IL RITORNO
Berescit e l’esagramma,
uno di fronte all’altro, stavano li da un po’. Regnava un gran silenzio
che li riempiva entrambi…
Alla fine l’esagramma non seppe contenere la gioia del vuoto e, come un
temporale improvviso, proruppe: “IO SONO il La che mi scuote e ti
scuote. Tradisco il silenzio per amore. Tradisco l’amore per l’amore.
Tradirò persino il tradimento. Avrei voluto tacere più forte questo
infinito silenzio, e mi sono mosso; mi sono vibrato, ricomposto. E
rimessi insieme i miei cocci, per vanità, mi canto.
Se qualcuno mi osserva, io muto, devo mutare. Ed ecco l’ennesimo
mio modo di essere: spezzetto l’anima mia in sei parti (sei ottavi) con
te.
E’ come fare cin—cin, ma nessuno mai potrà manifestare completamente la
gioia che sta al di là del canto dei cristalli.
Il calice è pieno di TAO, e pur dissetando, nessuno lo beve: cin-cin!
27 - ALIMENTAZIONE
Anna: Ha un
antipasto buono nel cestino, ma ce lo fa vedere da lontano, è un mondo
di sapori, ma va piano e ci costringe a starcene a digiuno.
L’antipasto c’è,
l’antipasto c’è, oggi è domenica, si mangia olè!
Angela: Chi versa
l’acqua tempera le mura di legno che la tengono legata, è una matita già
bene appuntita ma che continua la “temperatura”.
L’acqua
fresca c’è, l’acqua fresca c’è, oggi è domenica, si beve olè!
Cinzia: Lei crede
di cercare ed è cercata un po’ come la luce e l’eremita che cerca ciò
che porta: una “frittata” che se non va mangiata va perduta.
La
frittata c’è, la frittata c’è, oggi è domenica, si mangia olè!
Elena: Ha una
boccetta carica di luna, due gocce e vai per una settimana senza toccare
cibo. E’ un toccasana che non svapora: ‘na vera fortuna.
L’elisire
c’è, l’elisire c’è, oggi è domenica, si beve olè!
Vitt.: C’è chi
ha capito come cucinare è un pò come cantare o come dire, ma con il
gusto d’esserci e di fare: guidare il carro, “vivere” ed agire.
Chi
cucina c’è, chi cucina c’è, oggi è domenica, si mangia olè!
Gianni: Se vuoi
mangiare quello che ti piace, su dagli almeno il tempo che si cuoce se
non diventi “folle” non hai pace e digiunando tu rimani in croce.
Mezzo
folle c’è, ma forse non c’è, oggi è domenica, che famo?... olè!
Lored.: Il vino
della Forza è già versato, ce l’ha portato il giorno che venuta con un
leone accanto già domato, la Forza. Adesso su con la bevuta!
Anche
il vino c’è, anche il vino c’è, oggi è domenica, si beve olè!
Marco: C’è una
cipolla appesa d’annusare, l’ha appesa sua maestà l’Imperatore, è un
alto contributo per l’odore di tutte le portate da mangiare.
La
cipolla c’è, la cipolla c’è, oggi è domenica, s’annusa olè!
Margh.: Stavamo per
finire la cantata senza la pizza: proprio un’incompleta. Ma per fortuna
c’è la Margherita, il sole dei sapori già infornata.
C’è la
pizza c’è, c’è la pizza c’è, oggi è domenica, si mangia olè!
La comitiva brinda a
tutto spiano per festeggiare al solito “QUALCUNO” di cui, si parli forte
oppure piano, non riesce a dire niente mai nessuno. Lo si blatera, Lo si
indica, adesso a tavola: si mangia olè!
28 - La Preponderanza del Grande
1)
Mi piace vedere, in tale esagramma, una particolare fase dell’Opera
Alchemica: quella immediatamente prima della Dissoluzione. Non avendo
essa un nome (nessuno dei maestri ne ha mai parlato perché non è una
vera e propria fase), la chiamerò proprio la Preponderanza del Grande,
Ta Ko. Ma osserviamola meglio e più da vicino.
Quando il Vento dello Spirito soffia nell’uomo appena desto alla Vita
(sotto Sunn, il mite, il vento) le acque superiori si gonfiano (sopra
Tui, il sereno, il lago) e straripando ricolmano il risvegliato.
E’ un momento di Grande Potenza, poiché il Divino isordinata ed
incontenibile. A questo punto, sempre senza seguire schemi o maestri, si
cerca di entrare in meditazione, cioè in uno stato di quiete mentale
che dà certezza e consapevolezza di essere uno col Tutto, o meglio, che
solo il Tutto è, e noi siamo in Lui. Ora, per una persona che è
emotivamente alterata e mentalmente vigile come una tigre, riuscire a
stabilire la calma mentale è quasi impossibile: l’ego, la personalità,
il senso di “io sono io” è vivo e vegeto e l’esperienza è vissuta non in
comunione col Tutto, ma in separazione: un uccelletto, al primo volo
“conosce” l’aria che lo avvolge da tutte le parti, che gli da
vita, che gli permette di volare, che gli procura una ebrezza
incredibile, ed anziché prendere atto della propria piccolezza (in
quanto foa Sostanza, Essenza Universale) accade di sentire
la propria trave maestra piegata da un peso enorme. Ecco come ad una
personalità che sta per sfociare nell’oceano del tutto (sia pure per un
breve periodo) accade di puntellare da tutti i lati la propria apparente
individualità. E’ evidente che la dissoluzione non è avvenuta: il seme
è stato portato dal vento in un terreno fertile che lo ha accolto; sente
l’umido; sente il richiamo del sole; sa di essere un seme e di dover
quindi marcire come tale; ma per il momento preferisce rimanere seme,
sapere tutto questo, e vivere il momento di pressione del divino.
Siamo ancora lontani da ogni volo di corvi, e ancor più di colombi:
l’Opera è all’inizio, e la putrefazione, il totale abbandono alle acque
(non ci si dimentichi che è solo l’umido che la produce...) non è ancora
avvenuto. Per fortuna la trave maestra verrà solo piegata, perché ad
ognuno non verrà messo sulle spalle più di quanto possa sopportare o
portare.
2)
Quando il silenzio diventa parola, s’incarna. E’ come un fuoco sottile
che prende l’aspetto di sole, e che piano piano consuma se stesso nella
croce di tutto lo spazio ed il tempo.
Cos’è, nella gente, l’Essenza, se non un silenzio di mozzo, entro cui
per gioco, la giostra illusoria di un solo cavallo che gira crede di
essere un cerchio? Il Punto è un silenzio coagulato che porta con sè
tutti i mondi, è un unico Figlio di Dio, che, solo, da Dio può venire.
Il punto è la Pietra Angolare ch’è fuoco nel cuore.
La Sapienza è un aspetto del Grande Silenzio, l’aspetto formante di Dio,
è il Verbo vestito d’Amore che unisce le cose volute in un’acqua
infinita e infuocata.
E’ il Grande che crea
e ricrea,
pensiero di Dio che
dilaga
via come un mercurio
infinito:
si muove portando il
volere
del Padre di tutte le
cose,
volando.
Punto su punto, retta
su retta… ogni cosa è divina nell’Uno: appena un quadrato si crede di
essere altro dal Punto, è bugia, ignoranza, assenza di luce.
Ignoranza sei tu
quando parli e dimentichi di essere piccola foglia di quercia infinita.
Sei tu quando stacchi la presa e guardando altre foglie misuri uno
spazio apparente in un tempo apparente: la tua mano destra è copresente
alla mano sinistra: tu uno in te non hai né spazio né tempo…
Ignoranza è parlare;
è una smorfia alla Vita; un sole che cerca la luce; un’acqua che prova
la sete.
Sapienza è l’Unico
figlio di Dio, la semplicità dell’Uno Infinito.
SE SOFFIA SAPIENZA
PREPONDERA IL GRANDE
CHE PIEGA OGNI COSA
CHE AD ESSA SI PIEGA.
Prepondera il GranDe,
la trave maestra si piega, ed ogni cosa si scopre nell’altra: passaggio
del Punto, del Cristo.
29 L’ABISSALE
“L’ABISSALE è
l’acqua, i fossi, l’agguato, l’arco, la luna, ecc.”
(libro secondo dell’I King, pag. 550-551).
Con un piccolo salto, ci riesce facile passare dalla luna
all’immaginazione: quello strano aquilone che può farci volare fin su le
nuvole, se ben manovrato con mano e filo accorti.
Quando il caldo Vento dello Spirito soffia, abbandoniamoci come
fanciulli ad esso, lasciando che il nostro corpo dallo stato solido
(ghiaccio—mummia—morte) passi allo stato liquido (acqua—uomo—vita).
Il calore del Vento, dapprima ci solleverà come vapore, e dopo,
asciugandoci, ci assimilerà. Ora, se attraverso il filo, lo Spirito del
Vento scenderà e si fisserà, l’Acqua e il Fuoco, celebrando le nozze
spirituali, si uniranno indissolubilmente; potremo allora capire la
beatitudine provata da Pascal...
“L’anno di grazia
1654
Lunedì 23 Novembre,
giorno di S. Clemente, papa e martire,
ed altri al
martirologio,
vigilia di S.
Crisogono, martire, ed altri,
dalle dieci e trenta,
circa, della sera fino a circa
mezzanotte e mezzo
F U O C O
Dio d’Abramo, Dio di
Isacco, Dio di Giacobbe,
non dei filosofi e
dei sapienti
certezza, certezza,
sentimento, gioia, pace.” (Fulcanelli, Dim. Fil.)
Diventare acqua vuoi
dire andare alle radici, al mondo degli archetipi, per elevarsi
attraverso di essi, alla Causa Prima. Vuol dire abbandono cosciente,
tenace e mirante. Mirante perché l’abissale è anche l’arco con cui prima
si mira e poi si scaglia la freccia al bersaglio, alla meta di cui si
parla nell’immagine dell’esagramma.
Quando si tende l’arco e si scaglia, se non si è nella freccia e nel
bersaglio non si coglierà mai il centro; se si fosse solo la freccia,
nessun bersaglio si avvicinerebbe; se si fosse solo bersaglio, nessuna
freccia mai vi giungerebbe: la totalità del momento è la base di un
corretto tiro con l’arco, è Zen, Tao, Assoluto, Essere.
I pericoli dell’abissale, le buche in cui è possibile cadere, sono quei
vortici ove precipita colui che ha visto rompere il filo dell’aquilone
(vedi Nietzsche).
Il vento ha inghiottito l’aquila di carta, che lacerata è stata
rigettata in terra a brandelli contenenti confusi sapori del divino, la
Potenza del Suo Fuoco divoratore: una freccia impazzita ha perso di
vista il Bersaglio, e spinta dal vento si è costruito un labirinto di
traiettorie: quel che ama di più è l’ebrezza del volo, e di ciò fa una
meta sfuggente. Una pietra focaia che si è consumata in attriti potenti,
ubriacanti, che mai hanno acceso il F U O C O, il Dio di Abramo, il Dio
di Isacco, il Dio di Giacobbe.
E qui ci fermiamo, perché questa Luce Divina, infinita, questo Fuoco,
tutto divora essendo principio, dico Principio, di tutto: 1’Abissale,
l’acqua è tornata alle sue Radici: il F U O C O.
30 IL FUOCO
Jean D’Espagnes nel
suo “Trattato ermetico della fisica reintegrata” (1523), parlando un po’
qua un po’ la del fuoco, dice: “Questo fuoco della natura, insito nei
misti,…. ha domicilio nel cuore” e ancora: “il fuoco della natura è
duplice, universale ed individuale… l’universale ha sede nel sole, che
quale cuore dell’universo, effonde su tutte le plaghe un calore
vivificante, quasi il suo amore. Il fuoco individuale opera nel
suo microcosmo analogicamente”…
Ho sottolineato
apposta la parola “amore”, perché mi piace pensare all’amore come
essenza del fuoco.
L’esagramma, coi suoi
due trigrammi di fuoco, rende bene l’idea: fuoco macro-cosmico sopra,
fuoco micro-cosmico sotto a rispecchiare, riflettere, osannare il
“medesimo archetipo di tutte le creature”.
Dove sta l’amore? Sta
nel cuore dei due trigrammi: è quella linee spezzata, quel umilissimo
centro che vivifica tutto il composto. Come potrebbe il sole risplendere
in tutta la sua regalità se non fosse umile e tenero verso tutto il
sistema? Tutta la sua forza è in quell’apertura (in quella linea
spezzata) da cui il suo amore.
(Ogni centro è amore
perché è fuoco
perché è Dio)
Viene al mondo come
luce e calore, come vita. Quindi l’umiltà è figlia dell’amore, la figlia
mediana, mentre Sunn è la primogenita e Tui la terza figlia, il mite e
il sereno.
L’amore, dunque, è
prima mitezza, poi umiltà ed infine serenità; ed il
tutto è possibile riscontrarlo in tre fuochi “differenti”: un
fuoco temperato, un fuoco a bagnomaria, un fuoco
senza…. mantice. (“Differenti” è tra virgolette perché in effetti
sono diversi solo apparentemente: si tratta sempre di un fuoco non
violento, non divorante.)
Dare la vita, come fa
il sole ed il cuore, vuol dire “perderla” per se' ed acquistarla negli
altri (Luca, 9,23). Perché forse ancora non l’abbiamo realizzato, ma
ogni cosa grida a modo suo l’unicità del tutto che tutto contiene.
“Il fuoco filosofico
è un fuoco in potenza che non brucia le mani, ma che dimostra la sua
efficacia quando viene eccitato dal fuoco esteriore…. esso è della
stessa natura della materia filosofica… questo fuoco è adatto a
calcinare, dissolvere e sublimare la pietra dei filosofi”. (E’ quello
che scrive Linojon De Sainct Disdrer nel suo “Trionfo ermetico”).
Come non pensare al
seme, il cui fuoco interiore agisce solo al sole esteriore di
primavera….?
E andiamo ad
osservare ancora una volta l’esagramma 30 de I Ching: il trigramma
superiore è il fuoco esteriore, quello inferiore è il fuoco interiore,
la chioccia e l’uovo.
Nell’uovo il fuoco è
nascosto e va eccitato, è annacquato e va asciugato, etc. e il tutto
vien fatto solo con il fuoco della gallina, con un fuoco costante e
tenace. La gallina è proprio il trigramma superiore, è il sole + i
quattro elementi, è il (mercurio filosofico), mentre l’uovo è quel misto
stranissimo che ???. Senza il fuoco è impossibile compiere l’opera, come
senza il sole di primavera è impossibile far germogliare il seme.
Ma come si accendono
i fuochi? Tutti i filosofi, in proposito, tacciono. Ne parla un po’
Artefio, Lullo, Fulcanelli; ne parlano pochissimo altri; ma la maggior
parte tace. Esso è la chiave dell’opera, la quale non è altro che una
lunga cottura a diversi livelli. Diciamo solo che, come fisicamente, di
tanto in tanto, un fulmine, abbattendosi su un albero, lo brucia, così,
di tanto in tanto, per Grazia dell’Onnipotente, la Shekinah, lo Spirito,
scende su un essere umano e accendendogli il fuoco interiore, lo
illumina, lo fa germogliare a nuova vita, accende d’amore ogni suo
atomo, che da quel momento canterà la sacra vibrazione del Divino, il
Verbo; il Vero, il solo, l’unico fuoco che non distrugge e non divora,
ma che dona la vita. (Tale fuoco, però, può essere anche acceso, sempre
che Dio lo voglia).
Se osserviamo un albero da frutta,
notiamo come spesso una ramo è carico di frutti ed un altro no. Se
apriamo quei frutti, noteremo che alcuni hanno molti semi, altri pochi
ed altri ancora niente. Ebbene per l’umanità è lo stesso. Vorrei però
esprimermi in altri termini. Supponiamo che l’uomo sia una
lampadina… ve ne sono di tutte le
dimensioni e di tutte le forme: piccole, grandi, grandissime, semplici,
complicate, grosse, magre, sottili etc, etc, etc. La distinzione più
importante però è un’altra, quella che le divide nettamente in accese e
spente. Fra le prime spiccano quelle dei fondatori di religione. Esse
sono veri e propri fari che attingono la corrente direttamente alla
fonte: tutti possono vederli, la loro luce è indicativa del divino e
chiunque, attraverso la rotta personalissima, la sua unica
rotta propria può approdare al porto de Divino su cui il faro è
innestato.
Poi vi sono quelle
dei santi fondatori di ordini religiosi: sono fanali accesi nei giardini
del lungo mare, proprio vicino al porto del Divino.
Poi vi sono quelli
dei ricercatori, che assomigliano a quelle povere lampade appese al filo
pendente dal soffitto, le quali, tuttavia, illuminano la stanza in cui
stanno. Sono i cosiddetti fuochi immobili e casalinghi.
Dopo di questi vi
sono le lampade a gas, olio, batteria insomma quelle a tempo, le quali
sono convinte che è sufficiente accendere l’olio in dotazione per
brillare sempre.
Infine vi sono le
lampade spente: sono le più buffe di tutte. Alcune gonfiano sempre di
più il loro vetro, convinte che ingrassarsi sia il lo scopo
dell'esistenza. Altre girano con in mano la spina e il portalampada, ma
non sanno a cosa servono. Altre ancora sono convinte d’aver trovato la
fonte dopo aver scorto per un istante il loro filamento spento
nell’acqua specchiante. Altre ancora parlano della luce perché da
qualche parte ne hanno sentito dire. Una categoria a parte è quella
degli esoteristi: sono tutti con la spina in mano, ma col filo
imbrogliato ai piedi: per scioglierlo…. “si perdono” un sacco di prese e
qualcuno trova persino il tempo di criticare l’aggrovigliamento degli
altri.
E’ quello che
facciamo tutti, ed il fuoco aspetta…..
Il testo alchemico
più esplicito sul fuoco, è la Lettera sul Fuoco Filosofico di Giovanni
Pontano. Citiamo da un commentario al Mutus liber di Altus di Mino
Gabrieli (archè 74) che a sua volta cita M. Mazzoni, che cita Pontano:
“Per l’esercizio
intendi Sole = Oro = Zolfo = Anima = Cuore.
Prima fatti padrone
assoluto delle tue passioni, dei tuoi vizi, delle tue virtù; devi
essere il dominatore del tuo corpo e dei tuoi pensieri, poi accendi, o
veglia, per meglio dire, nel tuo “cuore” per immaginazione, il centro
del “FUOCO”; cerca di sentire da prima una specie di caloricità lieve,
dapprima ti parrà difficile; la sensazione ti sfuggirà; ma cerca di
mantenerla nel “cuore”, rievocala, ingrandiscila, diminuiscila a
piacere, sottomettila al tuo potere; fissala e rievocala a volontà.
Prova e riprova. Impadronisciti di questa forza e conoscerai il FUOCO
SACRO o FILOSOFICO”.
“… La pratica invero
è questa: si prende la materia e il più accuratamente possibile si triti
con tintura filosofica e si metta al fuoco e la proporzione del
fuoco si conduca in modo tale che ecciti semplicemente la materia, la
tocchi tuttavia, e in breve tempo quel fuoco, senz’altra opposizione di
mani, celermente compirà tutta l’opera, perché putrefarà, corromperà,
genererà e perfezionerà e farà apparire i 3 colori principali; nero,
bianco e rosso… Questo fuoco compie l’opera ed è la chiave di tutti i
filosofi…. se tu indagherai bene e profondamente le cose sante, la
proprietà del fuoco, la conoscerai e non altrimenti…”
Chi “ama il prossimo
come se stesso”, compresi quelli che ritieni nemici, Beato chi riesce, è
già entrato in Tiphereth e può cominciare; non altri.
30 IL FUOCO(2)
(Il re passeggia
nervosamente. Con lui, nella sala del trono, c’è il giullare, che gli
gironzola intorno e cerca di distrarlo con buffonate puerili).
Giullare: …. e fù così che
il grande giullare bloccò il povero re; olè, (gli tira il mantello
costringendolo a fermarsi.. Il re si gira e con l’indice puntato, in
crescendo di voce...)
Re: Se non la smetti
immediatamente ti faccio rinchiudere nella torre di ponente, a pane e
acqua, per un’intera luna. (gridando) E DOPO TI FARO’...
Giullare: ...ed ecco come
avvenne che il matto ubbidì alla voce della follia (pronuncia le due
parolette d’un sul fiato e velocemente mentre molla il mantello. Poi,
all’ennesima minaccia del re, cambiando tono) …ricordo a Vostra Maestà,
che sono pagato per far tutto questo, e rammento ancora che colui che mi
paga, è...Vostra Maestà. Tuttavia...la smetto e taccio, dopo aver
chiesto al mio signore...
(gli si avvicina, gli riprende il mantello con affetto)
…cos’è che oggi fa resistenza alla mia follia, vittoriosa sempre su
tutti i passati problemi di vostra sovranità? E’ triste, o mio re,
vedervi e sentirvi così. Parlate dunque; la riaffilata lama della mia
pazzia sconfiggerà ogni vostro nemico. Il fuoco del matto vincerà!.
(Il re si siede sul trono)
Re: Sentirti
parlare di bruciante matteria, amico mio, mi rattrista ancora di più,
perché, vedi, il mio problema è proprio un fuoco divorante che, strani
venti, soffiando, alimentano sempre di più. E non riesco a controllare
questa forza. Mi sento quasi come un poeta in preda al delirio di versi
che irrompono da tutte le parti, come un aquilone non più retto e
guidato, ma ormai in preda al vento. Ecco, mio caro ranocchietto, cosa
angustia il tuo re.
Giullare: Ah, ecco che
finalmente scorgo nelle vostre graziose parole il colore del fumo di
tale incendio.
Parlatene ancora signore, e saprò ben scoprire il
piromaneincendiariopirofilo. Vostra maesta' lo
consegnera' alle guardie... (va verso la porta, la apre e grida)
…guardie, guardie, tenetevi pronte,
perché tra poco... (il re l’interrompe, ed alle guardie...)
Re: Via, via di
qua! (al buffone) chiudi quella porta, e siedi qui, qui accanto e me:
il tuo re ha bisogno di parlare, e tu lo ascolterai. Ascoltami dunque,
ascoltami bene.
(il buffone
gli, si avvicina e siede sul pavimento ai piedi del trono)
Il FUOCO di cui ti parlo, è
un fuoco vecchio come il mondo, ma allo stesso tempo sempre nuovo e
sempre fresco, tanto che a volte sembra raggelarmi il sangue nelle vene
(lo invita a sedersi sugli scalini del trono) questa vita che si muove
dentro di me e dentro ogni cosa, un bel giorno ha alzato la voce, ha
vibrato più in fretta, ha cambiato l’ottava modulando in pianissimo. Un
mondo di legno, improvvisamente, ha preso fuoco. Ogni mio atomo
ritenendosi di diritto un sole da mezzogiorno e ritenendo, io, me
stesso, un universo di soli, pure stento a sentire il motore del fuoco
che avvampa di fuori e non trova la porta. (avvicina alla faccia del
giullare la sua faccia angosciata)
Mi consuma, mi asciuga, mi
divora, e non so come…. esserlo. (con voce strozzata). capisci!
Giullare: Vostra maestà è
distratta, sbadata. Davvero, mio re, non riesci e vedere la porta che tu
chiaramente mi mostri?
Re: Ma non capisci
che a divorarmi è la voglia di esserne il senso, l’essenza? E’ come se a
consumarmi fosse non quel fuoco, ma il fuoco di quel fuoco che sento qui
dentro, ma che non riesco a far incontrare con quello. E questo mio
volerli riunire è come un terzo fuoco, che...
(smette di
parlare e osserva naso contro naso il buffone) …riesci a capirmi?
Giullare: Ma è proprio
questa la porta, signor mio. Non hai sentito come un... quarto fuoco
arde nelle tue parole tanto da farle diventare disperata preghiera di
comunione? eccola qui la porta, e tu l’hai a dir poco spalancata: i
simili, e questa è una vecchia storia, si uniscono, ed ecco come di
tanti fuocherelli se ne crea uno, o meglio, ecco come il piccolo fuoco
del volere del cuore ha abbattuto le barriere che spezzettavano l’unico
fuoco che esiste, quell’antica Luce Primordiale con cui la Sapienza -
una con essa e con il Creatore - ha fatto, creato ogni cosa.
Quel fuoco è
un amore che unisce le genti e tutte le cose. Amare è bollire nell’UNO,
non più come acqua sul fuoco, me come spirito ardente. Il CUORE è la
porta: se metti ogni cosa la' dentro, costringi all’Essenza l’Amore, mio
sire. Quando si ama, o mia sovrana maestà, si è di più pur non avendo di
più, perché si comprende ciò che si ama e quindi ci si unisce ad esso.
Similia similibus, maestà: per fare l'oro ci vuole l’oro, per accendere
il fuoco occorre il fuoco. Ma in senso più generale, essendo l’Essenza
di ogni cosa FUOCO, è sufficiente essere. Maestà.... (ricomincia a
tirargli il mantello, il re si alza, si toglie la corona e la poggia sul
capo del folle, lo guarda e gli fa un inchino)...
30 IL FUOCO
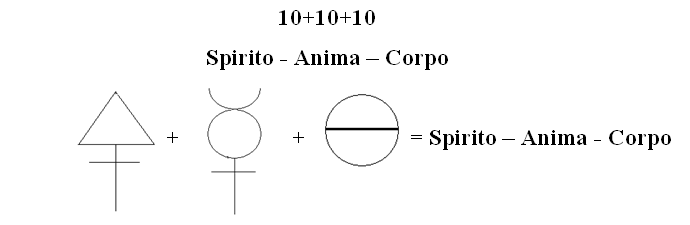
I filosofi dell’arte
(alchemica) danno il nome di fuoco anche al loro mercurio o acqua
celeste. E’ questo il fuoco che non brucia le mani. Lo hanno anche
chiamato naturale, perché è nella materia, ed anche contro
natura, perché riesce a fondere l’oro e spiritualizzarlo, cosa che
non riesce a fare il fuoco volgare.
Se per oro intendiamo la
persona comune che ha in sé la potenzialità del Santo, e per fuoco la
luce cosmica, il mercurio filosofico, il Cristo, ci rendiamo conto di
come questo fuoco che non brucia, quest’acqua che non bagna, se acceso
nella persona, spiritualizza.
E’ lo Spirito Santo, la
Shekinà, il fiume di luce, che scorre solo quando è stato acceso dentro
dalla Grazia, e qui parliamo del fuoco interiore, dello zolfo, dello
Spirito.
Ed eccoci all’esagramma: fuoco
sopra e fuoco sotto. Quando ciò accade vengono illuminate le quattro
regioni del mondo (immagine). Queste quattro regioni ci richiamano il
simbolo della croce che, in questo caso, rappresenta l’ordine che, nella
materia, è subentrato al caos: i quattro elementi che nel loro corpo
erano confusi, per effetto di questo fuoco doppio, si orientano ciascuno
verso il posto che gli compete: la persona prende atto di tutte le sue
componenti. Ecco che si lascia avvolgere da questo fuoco di cenere che
altro non è che il solito mercurio filosofale, la solita acqua divina
che non bagna, ovvero il solito fuoco che non brucia, e lasciandosi
abbracciare e avvolgere da tutte le parti, “si forma” un guscio di luce
(sarebbe meglio dire: lascia che un guscio di luce lo avvolga). E’ nato
il famoso vaso filosofico. Quindi il vaso non sei tu, è qualcosa che ti
contiene e che all’inizio ti procurerà un totale…. buio nell’Anima: sei
proprio un uovo che, grazie al fuoco cosmico, verrà covato e rivedrà la
luce dopo quaranta giorni: dal nero al bianco; dal piombo all’argento e
il tutto grazie al solo regime del fuoco, che dalla luna ti porterà al
sole, attraverso...
Chissà se le 6 varianti non
parlino proprio di questi 6 regimi?
1°: è il fuoco appena
acceso: scoppiettante e impaziente, quello di primavera.
D: è necessario accudirlo con
serietà e non ci sarà errore.
2°: è il fuoco del corposo
leone. E’ un fuoco maturo e responsabile.
F (come fuoco): il governo
(non dimentichiamo che il leone simboleggia il Re ed il cuore) è totale.
3°: è il fuoco
del sagittario, quello che cova sotto la cenere (anche di notte, il
fuoco filosofale va conservato…)
E: La vista
delle ceneri non deve ritener finita l’opera: la gallina cova sempre ed
il suo covare farà sì che dalle “ceneri” il giorno dopo il fuoco
riprenderà (fenice)
4°: I primi 3 fuochi sono
quelli da “usare”, gli ultimi 3 sono particolari.
B: Questo quarto è un fuoco
fatuo, di paglia.
5°: Questo è un
fuoco che ti fa sciogliere in lacrime, ti fa bollire troppo,
C: ma che ti monda da ogni
incrostazione.
6°: siamo alla circolazione
della luce: il pulcino è vivo e pronto a nascere.
A: quando il
fuoco cosmico circolerà in tutti i suoi canali energetici, romperà il
guscio (ciò avverrà nel leone).
Ciò che era entrato nel vaso
filosofico, non esiste più: dal caos all’ordine, dalla disarmonia
all’armonia, dal vile metallo all’oro: adesso si può risplendere.
Che Dio lo voglia.
31 L’INFLUENZAMENTO
La Pentecoste consolava tutti,
ricercatori, laici, belli, brutti,
e a ognuno j’assegnava de
parlare na' lingua tutta sua, particolare.
Mentre che je’ cresceva
ispirazione la folla dava vita a ‘n caciarone:
questo parlava a quello che
parlava e questo e quello niente ce capiva:
un
mongolo-fransè-greco-romano
in fronte a un
turco-rnechico-ottomano.
Io che dal Santo Spirito
scartato vivevo sta babele sconfortato, prorruppi na' richiesta con
passione dicenno forte: “O Dio der popolone
me devi proprio di’ che
devo fare, e subito, se no devo scappare:
ognuno va parlanno in
Benedetto ed io rimango qui come ‘nterdetto!”
Aspetto… e… giù na voce
vellutata
me dice seria: “Fatte na
cantata
senza badare
all’influenzamento.
Canticchia solo pe’
divertimento.
PARODIA DI “TANTO PE’ CANTA’”
La vita me pareva amara,
così, buttata la chitara,
ho messo bene ‘n pace er
core
e me so fatto cercatore
der vero, ma la mia
cercata,
dopo na grande faticata,
m’ha fatto capità ‘ndò
c’era
na compagnia senza
bandiera.
Stanno tutti là
smorfianno forte la Torà:
che coro!
Stanno a sistemà
la pietra, chè ne
scaturische l’oro.
Pe potello fà
te stann’ appende’ quanto
passa er cielo
sull’arberello che te
squarcia er velo
de li misteri e che te po
da er volo.
C’è un ramo carico de
gente:
Adamo ed Eva col serpente
vicino a Sara, proprio
quella
che gioca a fare la
sorella…
D’Abramo e poi l’Abimelecche
che ce ricasca senza
pecche,
Melchisedecche e un
Faraone,
che fanno ricco l’Alberone.
Stanno tutti là
speranno forte che je regga
er ramo,
tutti a traballà quanno che
arriva un ospite. Ce semo:
come reggerà?
Giacobbe arriva con le
quattro mogli:
sono già cinque e ciò
potrebbe annare
se non ci fossero dodici
figli.
C’è chi l’appende a
beverone,
chi con arguzie alla
Platone,
c’è chi li butta alla
rinfusa,
chi ci ha la mente un po’
confusa
e se ne sta così a pregare
che il vento faccia
decollare
sti personaggi molto strani
che vadan soli su pe’ i
rami.
Stanno sempre là
sotto quell’arberò dei
sefironi
tutti a cabballà,
tra numeretti grafici e
spintoni
vanno avanti ma
verso che dove nun sappiamo
bene.
All’apparenza sono dei
santoni,
nella sostanza dei
giocherelloni
31
L’INFLUENZAMENTO
L’influenzatore aveva già
camminato per più di un’ora, ma la sua disperata ricerca di qualcuno da
influenzare era stata vana. Certo, l’ora non era favorevole, alle cinque
del mattino la metropoli dorme ancora, però lui non disperava, e ad ogni
incrocio volgeva lo sguardo a destra e a sinistra con lo stesso stato
d’animo con cui il pescatore cala la lenza.
Finalmente, all’incrocio
con la 31a strada, la cosa accadde: un altro uomo della città
sarebbe stato influenzato, con buone probabilità di divenire, a sua
volta, influenzatore.
Qui bisogna aprire una
parentesi per dire chiaramente come stavano le cose. Ebbene, non è che
il nostro amico nelle due ore di ricerca non avesse incontrato nessuno,
anzi. Quella città, per l’80%, era composta ormai da influenzatori
provetti, tanto esperti che funzionavano quasi come delle radio: si
autoaccendevano ad ogni incontro e offrivano la sintonizzazione
all’influenzando, il quale, in pochissimi secondi, avrebbe trovato la
giusta frequenza per, nientemeno, il Divino. E tutto accadeva attraverso
quella perfetta radio che era l’influenzatore.
Ecco come il nostro amico
aveva incontrato molti… colleghi che aveva regolarmente ignorato e da
cui era stato cordialmente ignorato.
Ma torniamo al fatto, per
assistere personalmente ad un influenzamento, alla propagazione di un …
direi quasi contagio spirituale. Quella persona sarà per il nostro
“untore” angelico come un pezzetto di legno da aggiungere al fuoco della
sua insaziabile sete di essere Verbo incontrastato del Divino.
Il nome del fortunato è
Lucien e sta spazzando il marciapiede della 31a mentre
canticchia:
Lucien: Il
pesce da pescare non sta su questa terra, ma nell’immenso mare che non
conosce guerra. Le strade da spazzare son tante, e con pazienza bisogna
mantenerle con forza e con costan...
Influenzatore: Avrebbe
da accendere, buon uomo?
Lucien: Certo,
signore, tutti hanno da accendere.
Infl.:
(mostrando una sigaretta fra le dita) ebbene?
Lucien: Ebbene,
cosa?
Infl.: Ebbene,
mi faccia accendere.
Lucien: Ma lei,
signore, mi ha chiesto solo se avevo da accendere.
Infl.:
Infatti, e lei mi ha detto di si. O no?
Lucien: Si, si,
certo, io ho da accendere, ma vede….
Infl.:
(interrompendolo) no, no. Mi basta questo: lei ha da accendere, (mette
la sigaretta fra le labbra) MI FACCIA ACCENDERE! deve solo tirar fuori
una cosetta così, sfregarla, e avvicinarla qui (indicando la sigaretta).
Lucien: Ma non è
il caso che si arrabbi, signore. Io ho detto sì che ho da accendere, ma
non qui. Vede, io, i… fiammiferi... li tengo a casa. Ogni mattina ne
prendo uno, e lo faccio bastare per tutto il giorno.
Infl.: Tutto
il giorno! (Lucien annuisce). Lei vorrebbe farmi credere che.. accende
una sigaretta di mattina con… un solo fiammifero, e poi, di sigaretta in
sigaretta...
Lucien: Ma io non
fumo, signore, non ho mai detto di fumare, non sono così stupido da
fumare.
Infl.: Ma come
si permette! lei mi sta offendendo. IO FUMO!
Lucien: Non mi
permetterei mai, signore. Mi spiego meglio. Un tempo fumavo, ma avevo
sempre mal di testa, mal di denti, tosse; ed in più spendevo un sacco di
soldi. Un giorno decisi di smettere, e smisi. Ed ecco: via mal di testa,
via mal di denti, via tosse e via spese inutili. In poche parole, non
feci più male a me stesso, e giudicai il me stesso di prima uno sciocco
e uno stupido. Io parlavo di me, signore, non di lei. Non mi permetterei
mai di offendere una così degna persona.
Infl.: Senta,
io a lei non la conosco; non mi ricordo più che ci faccio a quest’ora
insolita qui quando dovrei essere a letto. Al momento ho un solo, unico,
grosso, infinito problema (gridando e con gli occhi fuori dalle orbite)
devo accendere, CON ESTREMA URGENZA,, questa sigaretta, SE NO MI
ARRABBIO!
Lucien: Ma lei,
signore, è già arrabbiato, e questo fa male, E’ quasi come fumare: uno
fa male a se stesso, e quindi....
Infl.: …e
quindi sarei uno stupido (gli si avvicina minaccioso) CE L’HAI O NO
QUESTO CERINO? (abbassa la voce in tono supplichevole) devo
assolutamente fumare. Capisci? d e v o f u m a r e.
(passa un altro
influenzatore)
2° infl.: Scusate
fratelli, avreste da accendere? (e mostra un sigaro).
1° infl.: NOO!
(il 2° infl. scappa)
Adesso, tu ed io, andiamo a
casa tua (si guarda intorno e poi grida) Taxì! E siccome le tabaccherie
sono tutte chiuse, lì prenderai il fiammifero n° 2, oppure quello di
domani o quello di un altr’anno, e farai accendere la sigaretta al tuo
fratellino. CAPITO?!
Lucien: Certo
signore. (saluta il tassista) ciao Martino, a casa per favore.
Infl.: Scusi
buon uomo, non è che per caso ha un fiammifero?
Taxista: Niente da
fare signore. Mai fumato, mica sono stupido sa.
Infl.: Perché
secondo lei, tutti i fumatori, tutti noi fumatori, siamo degli stupidi.
E’ COSII'?
Taxista: Mamma mia
che giornata! e sono appena le sei. Fortuna che siamo arrivati. Signori
si scende: 11° strada n° 30. 5 dollari giusti… grazie.
(Lucien e Infl. salgono al
4° piano, int. 63. Il primo apre la porta e cedendo il passo)
Lucien: Signore,
sono onorato di riceverla in casa mia. Casa piccola, ma… pulita.
(Infl. data appena
un’occhiata dentro scoppia in una sonora incontenibile risata: scope:
scope dappertutto, alle pareti, sul tavolo, sulle sedie)
Infl.: Sfido
che è pulito. Quante saranno 100, 200...? Capisco che lei è spazzino e
che ci lavora, ma tutte queste!
Lucien: Premesso
che non sono spazzino, signore, le dico subito che pur essendo tante,
mi creda, non mi bastano mai.
Infl.:
(ricominciando a ridare) non gli bastano...
Lucien: Ma lo sa,
signore, perché con l’autista ci diamo del tu?
Infl.: E
questo cosa c’entra con le scope?
Lucien: C’entra e
come signore, e le dico perché. Lei è già la terza persona che porto a
casa stamattina, e da qui a stasera ne porterò altre venti minimo. La
prima persona della giornata mi aveva “agganciato” con la vecchia
battuta del tempo; la seconda col “che ore sono?”; e la terza (lo indica
invitandolo a parlare)
Inf1.: La…
terza… sarei…. io… beh, le ho chiesto…. (improvvisamente si ricorda) ma
certo, le ho chiesto di farmi accendere: ma mi vuole fare accendere
questa benedetta sigaretta o no?
Lucien: Io so solo
che lei ha bisogno del fuoco e glielo do subito (prende una scopa e
gliela passa) ecco.
Infl.:
(prendendo la scopa con incredulità) e con questa che ci faccio?
Lucien: E che ne
so io? Ormai è sua e la cosa non mi riguarda.
Infl.:
(sbalordito) ma io ho chiesto solo di avere un cerino, un pò di fuoco!
ed a momenti non so più chi sono e da dove vengo, ed in più dopo un paio
d’ore dalla richiesta mi ritrovo ancora la sigaretta spenta ed una scopa
in mano, “che” non so che farmene. (minaccioso) Ho capito tutto: tu vuoi
farmi ammattire. Attento sai: potresti essere la prima vittima del tuo
golem!
Lucien: Va bene.
Basta così. Ti spiegherò tutto se mi lascerai parlare. Prometti?
(Infl. fa cenno di si con
la testa)
Ebbene, devi sapere che la
città ormai è divisa fra influenzatori e liberi spazzatori. 80% voi, 20%
noi. A differenza della vostra, la nostra associazione si è riunita una
sola volta, all’inizio, ha preso la decisione e poi ha lasciato ad
ognuno degli associati la libertà di usare il tipo di scopa più adatto.
La decisione era questa:
spazzare ogni tipo di confezionamento dell’Assoluto. Mi spiego. Il primo
influenzatore ha proposto un Dio bell’e confezionato al 2° influenzatore
che, senza nemmeno darsi la pena di sconfezionare, l’ha passato al 3°, e
così via. Ora, siccome siamo tutti pensionati con un sacco di tempo a
disposizione e amanti della libertà assoluta e del divertimento lecito,
ci siamo divisa la città in settori ed ognuna si diverte nella “sua”
zona. Devi anche sapere che quelle scopa lì è un simbolo, quello
dell’incessante pulizia interiore che siamo costretti a fare. E’ come
avere un arco nel cuore e mille arcieri., anziché uno solo, i quali
tendono la corde ciascuno nella sua direzione. Noi siamo uno, ma loro
sono mille e siccome non possiamo spezzettarci, occorre prima farli
tacere e poi convincerli che sono solo pezzetti di creta animati da una
nostra parte di energia. Spazzare significa ridurre il tutto a creta,
per poi fare un unico arciere. Ovviamente, l’ultimo arcierino è lo
spazzatore, anche quello dovrà incretarsi e poi vi sarà un silenzio: la
casa sarà pulita, e forse, allora, nascerà l’Atteso. Sai, nessuno te lo
può confezionare: o nasce dentro oppure è qualcos’altro. Se qualcuno ti
“assale” per passarti il divino, diffida: hai mai visto una madre
svegliare il proprio bambino a scossoni? Noi siamo della gente
straordinariamente ordinaria, abbiamo solo il buon senso di cercare la
torta seguendo l’odore delle pasticceria, piuttosto che quello
dell’ammoniaca della smacchiatoria. Beh?
Infl.: Mi fai
accendere per favore.
Lucien: T’ho già
detto che non fumo, e se ancora non l’avessi capita, l’unica cosa che ti
posso dare è quella scopa lì.
Infl.: Ma… io
che ci faccio qui?
Lucien: E io che
ne so, mi ci hai costretto tu a venire.
Infl.: Dimmi,
come hai smesso di fumare?
Lucien: Semplice:
non ho mai cominciato, dopo avere smesso.
Infl.: E se
tu fossi me e volessi smettere?
Lucien: Semplice:
prima deciderei, poi smetterei, quindi…. Spazzerei.
Infl.:
Spazzeresti che cosa?
Lucien: Le
velleità di quel piccolo arciere che vorrebbero costringere 100 Kg.
d’uomo sapiens e tendere l’arco verso... un po’ di fumo.
(Infl. guarda Lucien,
guarda la scopa, riguarda Lucien)
Influenzatore: Beh, credo
proprio che la terrò. (va)
Fine
|